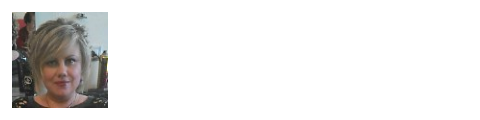“Psicoterapeuti dell’anima”. Ma l’anima che cosa c’entra con la psiche? Non sono forse due dimensioni molto diverse? Dell’anima dovrebbe semmai interessarsi il prete, non lo psicologo. Sbaglio? Ma forse l’anima interessa anche la psiche ; oppure no…. I moti dell’anima interferiscono sul cervello?”
Diciamo intanto che parlare di “psicoterapeuti dell’anima” è una espressione riassuntiva per indicare un tipo di dialogo interattivo fra due persone: una che è portatrice di una sofferenza che ha colpito il mondo dei suoi pensieri, dei sentimenti, delle emozioni, delle relazioni sociali, della percezione di sé e del proprio passato, presente e futuro, e che le impedisce di vivere in modo armonioso la propria vita ; l’altra che, soprattutto attraverso il dialogo, cerca di capire, di comprendere il proprio interlocutore e di aiutarlo a sua volta a cogliere le radici o il significato della sua sofferenza, per trovarvi rimedio e sollievo.
Questa seconda persona, che con la propria competenza professionale, con la propria preparazione e disponibilità “umana”, con la propria capacità di “leggere e interpretare” il mondo dell’altrui sofferenza e con la propria “arte” della parola e della persuasione aiuta, sostiene e cerca di “guarire” il proprio interlocutore, è, appunto, uno “psicoterapeuta dell’anima”.
Dopo questa iniziale precisazione, che definisce per sommi capi l’orizzonte della parola “psicoterapia”, può rimanere tuttavia ancora problematico l’orizzonte di significato della parola “anima”. La problematicità del concetto di anima è legata all’essenza sfuggente e si potrebbe dire “imprendibile” del cosiddetto “oggetto” che la parola dovrebbe designare. Esiste un “oggetto-anima” allo stesso modo con cui esiste un “cervello”, un “cuore”, un “fegato”, uno “stomaco” o un altro qualsiasi degli organi interni? Quando parliamo di una sofferenza cerebrale, epatica, cardiaca, gastrica o altro, ci riferiamo a patologie individuabili e valutabili mediante strumentazioni e analisi di tipo “oggettivo”, caratterizzate da valori quantificabili. Ma quando parliamo di un comportamento “ossessivo-compulsivo”, che produce ansia, angoscia, rigidità e ripetitività coatta di sequenze di azioni, abbiamo un “oggetto” o un “organo” specifico cui riferirci?
Possiamo parlare, sì, di “sofferenza dell’anima”, ma il concetto di anima rifletterà sempre il significato greco della parola, che è “anemos” = soffio, alito, vento, e cioè un “quid” evanescente e vago, che è dovunque ma nello stesso tempo in nessun luogo.
La “impalpabilità” dell’anima è un dato di fatto, ma è anche vero che senza questo “soffio” che si insinua dovunque, che guida il nostro comportamento, suscita i nostri pensieri, le nostre emozioni, i nostri sentimenti,la nostra creatività, che ci mantiene in vita e che ci esalta, ci abbatte, ci fa soffrire, ci fa sperare e ci fa agire nel bene come nel male, noi non esisteremmo, e neppure gli stessi organi del nostro corpo potrebbero funzionare.
L’anima è la grande attrice nel palcoscenico della nostra vita ; personaggio unico e sublime dai mille volti e dai più impensabili travestimenti ; sa apparire abile ed accorta nel regolare, dirigere e armonizzare il grande concerto sinfonico del nosto corpo ; sa diventare miserabile, meschina o diabolica nel mettere in subbuglio la nostra vita mentale ed amotiva ; riesce ad essere aperta alla meraviglia, ad essere eroica, sublime, intrepida nel volgersi al mistero della natura e del trascendente. Noi la possiamo “sorprendere” nel suo “apparire”, e qui possiamo dialogare con lei e in qualche modo “curarla”, quando il suo apparire è sofferenza. Ma in ogni caso, come diceva l’antico filosofo greco Eraclito, “per quanto si possa camminare, non raggiungeremo mai gli estremi confini dell’anima”. Sul modo polivalente di manifestarsi dell’anima ci sarà sempre spazio per il medico, per lo psicologo, per il sacerdote, per il teologo, perchè “infinito è il suo Logos” (cioè la sua essenza), come, ancora, diceva Eraclito.