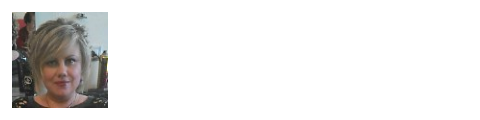Proprio oggi, una persona mi ha posto un quesito che, seppur dettato da una seria sofferenza interiore, non può non fare riflettere.
Siccome la persona ha acconsentito a rendere pubblica la sua domanda, ne riporto per intero il testo, con tutte le doverose modifiche che tutelino rigorosamente l’anonimato della scrivente.
“Volevo sapere se lei si occupa di consulenza filosofica. Perchè dopo 12 anni di psicoterapia ho cambiato tipo di aiuto. Mi sono rivolta ad una consulente filosofica, ma sono fortemente in crisi…. Mi piaceva sapere se lei pratica questa professione e se crede in questo tipo di aiuto per affrontare i disagi dell’anima. La mia anima è stata fortemente messa a dura prova dalla vita …. e non trovo la strada per tornare a vivere e non sopravvivere!
Se ha tempo puo’ dare un’occhiata alla pagina “Chiedi aiuto alla Filosofia”. Tramite essa mi sono messa in contatto con una professionista che dice di occuparsi di consulenza filosofica in alternativa alla psicoterapia. Io sto riflettendo su cosa fare. La percepisco come una persona professionalmente preparata, ma io abito a Milano e lei in un’altra città. Questa consulente mi prenderebbe in carico effettuando le sedute telefonicamente …. Ho tanti dubbi …. Cosa ne pensa? Mi dia solo un suo parere ; Le assicuro che non avra’ alcuna responsabilità sulle mie scelte.”
La figura del “Consulente filosofico” è una nuova “presenza” professionale che oggi accresce la già ben nutrita galleria delle offerte terapeutiche che si propongono di alleviare o “curare” l’umana sofferenza. Senza entrare in merito alla configurazione legale del problema, che riguarda la legittimità o meno di poter “invadere” un territorio tradizionalmente riservato agli psicologi, psicoterapeuti e medici-psichiatri – territorio peraltro regolarmente tutelato da specifici albi professionali -, è giusto chiedersi se la Filosofia possa assumersi il compito specifico di “curare” i disagi delle persone, e, se del caso, “quali” tipologie di disagi.
Se si escludano le tradizionali “categorie” cliniche di sofferenze psichiche, che richiedono interventi di più specialistica competenza, sembra che la consulenza filosofica non possa che rivolgersi se non a quell’area delle problematiche esistenziali, che potremmo racchiudere sotto la comune denominazione di “male di vivere”.
Un “male” assai diffuso in particolare nella nostra epoca, dove la “cultura della precarietà”, dilagante in tutti i campi della vita, rende insicuro l’esistere, mettendone a repentaglio il senso.
Fin dal secolo XIX e poi, soprattutto, nel secolo XX, dopo le due guerre mondiali, vi furono correnti filosofiche che già mettevano in risalto il senso di precarietà della vita umana. La principale di queste filosofie fu l’Esistenzialismo (Kierkegaard, Heidegger, Jaspers, Sartre, Marcel, Abbagnano, per citare i nomi più prestigiosi).
L’Esistenzialismo, nel polivalente panorama degli indirizzi filosofici, è stata indubbiamente la filosofia che maggiormente si è addentrata nell’analisi della condizione di tragica e solitaria sofferenza in cui si trova l’uomo nel suo essere-nel-mondo.
Per questa sua peculiare caratteristica, l’Esistenzialismo ha prodotto spesso sofisticate ed approfondite analisi della psiche umana, al punto di attirare l’attenzione degli psicologi e degli psichiatri, che sovente si sono serviti dei contributi di questa filosofia, trasferendoli in ambito psicoterapeutico. Si pensi, ad esempio, a Ludwig Binswanger, il grande psichiatra svizzero, che tentò, dagli anni ‘ 30 agli anni ‘ 60, una interessantissima sintesi fra la psichiatria e il pensiero di Heidegger, con esiti rivoluzionari sul piano della cura della malattia mentale ; così come hanno fatto anche altri illustri psichiatri e psicologi, che dall’Esitenzialismo hanno tratto ispirazione per “curare” la sofferenza umana, come Victor Frankl e gli psicologi e psichiatri statunitensi, che fondarono la “Psicologia esistenziale”, e la “Psicologia umanistica” (May, Allport, Murphy e altri).
L’incontro storico fra Esistenzialismo, Psicologia, e Psichiatria testimonia, certamente, come la Filosofia non sia poi così lontana dal territorio delle scienze della psiche umana ; tuttavia il problema che rimane aperto è se si possa fare un uso “clinico” di essa, senza stravolgere la più intima ed essenzaile natura della Filosofia stessa.
Il pensiero filosofico, nella sua più intima essenza, è un tipo di riflessione che ha sempre mirato a fornire risposte di carattere “generale” ed “universalistico” ai quesiti sul senso della vita e della realtà in genere, che fin dalle epoche più antiche hanno tormentato la mente umana. Tali risposte hanno sempre avuto una portata di carattere sovraindividuale, nel senso che mai hanno posto attenzione particolare alla condizione specifica della singola persona. In filosofia, quando si parla di “condizione umana”, ad esempio, si allude alla “Umanità” in generale, non al singolo individuo, storicamente, geograficamente, culturalmente determinato, con la sua personale biografia e con l’assetto del tutto unico ed irripetibile della sua presenza nel mondo.
Questo versante del tutto particolare è stato sempre sostanzialmente assente dal pensiero filosofico. Anche lo stesso Esistenzialismo parla della “esistenza umana” in generale e non delle vicende specifiche del singolo “esistente”. Gli psicologi e psichiatri che si sono “ispirati” all’Esistenzialismo, ne hanno utilizzato il linguaggio, come fonte preziosa e suggestiva di arricchimento delle categorie cliniche in uso nelle scienze “mediche”, ma si sono staccati dalla Filosofia vera e propria quando doveva essere affrontata la dimensione “clinica” della sofferenza del singolo.
Sicuramente il linguaggio filosofico ha portato una ventata di novità nel campo della ricerca sulla sofferenza esistenziale, educando ad una nuova modalità di ascolto e di interpretazione dei disagi psichici, soprattutto per quanto concerne la loro cornice umanissima ; ma lo “scarto” fra la “vocazione” squisitamente universalistica della riflessione filosofica e l’orizzonte “clinico”, cioè individuale, della psicoterapia, rimane e rimarrà pur sempre una sostanziale differenza qualitativa nell’approccio alle problematiche umane.
Tutto questo nulla toglie al fatto che poi, su di un piano pratico, molte persone possano anche “trovare conforto” alle loro individuali sofferenze, leggendo, dialogando, e ripensando il “romanzo” della propria vita in termini filosofici, con l’aiuto di un “consulente-filosofo”, piuttosto che affidarsi ad uno specifico percorso psicoterapeutico. Se questo “sollievo” interiore viene felicemente raggiunto mediante la Filosofia, ben venga : come un tempo si diceva : “tutte le strade conducono a Roma”. Chi si occupa autenticamente del benessere delle persone e non della tutela arrogante del proprio territorio di competenza, cioè chi si occupa non esclusivamente della “malattia”, ma del “malato”, non potrà che essere soddisfatto.