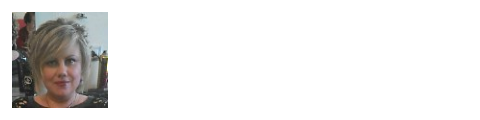Quando frequentavo la scuola elementare, la maestra, un giorno, ci parlò di Cornelia, la famosissima madre dei fratelli Gracchi, la quale soleva dire dei suoi figli : “Questi sono i miei gioielli!”
Questa frase mi affascinò subito, e sperai che anche mia mamma la potesse pronunciare, o almeno pensare, nei confronti di me, di mia sorella e dei miei fratelli. Ho la quasi certezza che lo abbia fatto, anche se non alla maniera di Cornelia, visto lo straordinario affetto che ancora oggi testimonia in mille modi verso di noi.
Però, durante l’adolescenza, quando ero una ragazza romantica (ma lo sono ancora oggi, in verità!), sempre desiderosa di curiosare fra i poeti, mi imbattei in un libro del grande poeta, pittore e filosofo libanese-americano Kahlil Gibran (1883-1931), “Il Profeta”, dove mi colpì altrettanto profondamente un discorso che il protagonista – il Profeta, appunto – fa ad una madre che gli chiede di parlare dei figli, dall’alto della sua sublime saggezza. Un discorso poetico sorprendente, che mi obbligava, forse, a rivedere la mia ammirazione d’un tempo per Cornelia.
Il libro di Gibran è famoso, ma vale sempre la pena di rievocare quelle vibranti parole.
“I vostri figli non sono i vostri figli.
Sono i figli e le figlie della brama che la Vita ha di sé.
Essi non provengono da voi, ma per tramite vostro,
e benchè stiano con voi, non vi appartengono.
Potete dar loro il vostro amore, ma non i vostri pensieri,
perchè essi hanno i propri pensieri.
Potete alloggiare i loro corpi, ma non le loro anime,
perchè le loro anime abitano nella casa del domani,
che voi non potete visitare, neppure in sogno.
Potete sforzarvi d’essere simili a loro,
ma non cercate di renderli simili a voi.
Voi siete gli archi dai quali i vostri figli
sono lanciati come frecce viventi.
L’Arciere vede il bersaglio sul sentiero dell’Infinito
e con la forza vi tende
affinchè le sue frecce vadano rapide e lontane.
Fatevi tendere con gioia dalla mano dell’Arciere,
perchè se egli ama la freccia che vola,
ama ugualmente l’arco che sta saldo.”
Più tardi ancora, quando ero assai più adulta, un’altra poesia entrò dritta nel mio cuore, mentre leggevo un libro di Antropologia Culturale della grande antropologa americana Margaret Mead (1901-1978). Scopersi che la studiosa aveva dedicato dei versi alla propria figlia Cathy. Versi stupendi, che mi ricordarono nuovamente quelli di Gibran.
“Che io non sia un inquieto fantasma
che segua ossessivo l’andare dei tuoi passi.
Al di là del punto in cui mi hai lasciata,
ferma in piedi sull’erba appena spuntata,
tu devi essere libera di prendere un sentiero
la cui fine io non senta il bisogno di conoscere
né la febbre affliggente di essere sicura
che sei andata dove io volevo tu andassi.
Quelli che lo fanno cingono il futuro
fra due muri di ben disposte pietre,
ma segnano un cammino spettrale,
un arido cammino per ossa polverose.
Dunque, tu puoi andare senza rammarico,
lontano da questo paese familiare,
lasciando un tuo bacio sui miei capelli
e tutto il futuro nelle tue mani.
(“L’inverno delle more”,
Milano, Mondadori, 1977)
Adesso che son passati altri anni e sono madre di due figlie, alle prese col difficile compito della loro educazione, il ricordo di Cornelia, e i versi di Gibran e della Mead risuonano spesso nella mia mente, non più come espressione di teoriche dispute pedagogiche, ma come veri e propri dilemmi, spesso conflittuali, su come impostare le mie “proposte” educative.
Non sono pochi i momenti in cui, dinanzi al meraviglioso spettacolo della crescita delle mie figlie, del loro gioioso inoltrarsi nella vita, dei loro primi entusiasmi dinanzi al variopinto, ma anche sconcertante e contraddittorio spettacolo della realtà di oggi ; dinanzi alle loro prime e per me imbarazzanti richieste di autonomia ; dinanzi alle inevitabili dialettiche che tali richieste provocano, perchè suscitano ansia, tensione e talvolta anche irritazione : non sono poche, dicevo, le occasioni nelle quali mi sono trovata a dover prendere una decisione sulla traiettoria educativa da seguire.
Cornelia, oppure Margaret Mead, confortata da Gibran? Devo considerare le mie figlie come i “miei” gioielli, capolavori di “mia” proprietà, “prosecuzioni di me stessa”, che possono e “devono” essere come “io” le voglio ; oppure mi devo progettare nei loro confronti togliendo l’aggettivo possessivo “mio” ed ogni altro riferimento a me stessa e ai miei personali bisogni, per lasciare che esse divengano, sì, “gioielli”, ma di se stesse? Le mie figlie devono essere “prodotti” del mio personale narcisismo, oppure la mia funzione di madre è un’altra? E come gestire la mia ansia e la mia istintiva contrarietà quando le loro richieste ed i loro comportamenti divergono dalle mie aspettative, oppure mettono in crisi la mia personale ricerca di tranquillità?
Sono domande pesanti, che in più occasioni hanno tormentato le mie notti e messo a dura prova il mio desiderio di essere non solo madre, ma anche e soprattutto una “buona” madre.
Poi, ecco, d’improvviso : una prima risposta sorprendente, chiara ed immediata, a tutte queste scottanti domande mi è stata suggerita casualmente proprio dalla mia figlia maggiore, quando recentemente, di ritorno da scuola, mi ha chiesto di spiegarle meglio il significato di quei capolavori di Michelangelo Buonarroti, che sono le statue dei cosidetti “Prigioni”.
Ricordo ancora la profondissima suggestione che già quelle statue così potentemente enigmatiche avevano esercitato su di me, quando, da adolescente, le avevo viste per la prima volta sfogliando una pubblicazione sulla Galleria dell’Accademia di Firenze, dove queste statue inquietanti sono situate vicino al meraviglioso David.
Quattro statue (più altre due, che si trovano al Louvre di Parigi), volutamente lasciate incompiute dal genio di Michelangelo, il quale, proprio attraverso quella stessa incompiutezza, volle forse rappresentare lo sforzo immane e tormentato dell’uomo che cerca faticosamente di prendere forma, liberandosi dal carcere della materia caotica (il marmo grezzo), che vorrebbe tenerlo prigioniero soffocando in lui ogni speranza di Libertà e di Bellezza.
Una lotta titanica, che i volti e i corpi di ciascuna statua, contratti e in torsione in modo spasmodico per la fatica di “nascere” a nuova vita, “emergendo” dal marmo, testimoniano mirabilmente, dimostrando, fra l’altro, ciò che Michelangelo intendeva per arte della scultura. Un’arte che “si fa per via di levare” (sono parole sue), dove lo scalpello dello scultore non impone una forma predefinita, ma, con la sua intelligenza, quasi “aiuta” la materia a “produrre”, a “partorire” la forma che in essa é come “nascosta” in modo indifferenziato (altrove, Michelangelo stesso dice in versi :“Non ha l’ottimo artista alcun concetto / c’un marmo solo in sé non circonscriva / col suo soperchio, e solo a quello arriva la man che ubbidisce all’intelletto” (cfr. Michelangelo Buonarroti, “Rime, Sonetti”, 62, Milano, Garzanti, 2006, pag. 154) : l’artista che veramente vale, non possiede mai un’idea che non sia già racchiusa nel marmo informe ; solo la sua mano, guidata dall’intelligenza, la può svelare e liberare).
Ebbene, mentre spiegavo a mia figlia, con crescente entusiasmo, questo lato nascosto dell’arte scultorea di Michelangelo, mi è balzata in mente, in modo repentinamente chiaro, l’idea che fra le pieghe degli sforzi michelangioleschi di “far partorire” al marmo la “forma” artistica che in esso è potenzialmente contenuta, vi sia implicita anche l’immagine progettuale di quella che potrebbe essere la “vera” Educazione dei figli.
I nostri figli sono, metaforicamente, come pregevoli, meravigliosi blocchi viventi di preziosissimo marmo di Carrara. Noi quel marmo lo abbiamo cercato con amore palpitante, lo abbiamo scoperto e portato alla luce traendolo fuori dalle più profonde e remote cavità della montagna della Vita.
Adesso dobbiamo essere come lo “scalpello” dello scultore che aiuta quel marmo puro, vibrante e vitale a “prendere forma” ; non la forma che “noi” vogliamo, ma la forma che in quel marmo è nascosta da sempre, e che noi dobbiamo aiutare gradatamente a “liberarsi” dalla prigione della materia, dal regno del puro possibile, perchè divenga realtà splendida e vivente. E non importa se quella forma non sarà come noi, nel nostro egoistico narcisismo, avremmo desiderato ; l’importante è che essa sia l’espressione autentica della più intima “vocazione” esistenziale dei figli.
Ma, come suggerisce mirabilmente Michelangelo, lo scalpello che “leva” la forma dalla materia, deve anche essere guidato dall’intelligenza. Ed io penso che, nel rapporto con i figli, questo “intelligente scalpello” consista soprattutto nella capacità di “ascoltarli” con paziente amore, immedesimandosi in loro.
Molti genitori che spesso incontro, non hanno mai il tempo e, ancor peggio, il desiderio di dedicarsi all’ascolto e al dialogo con i propri figli. Si limitano a sforzarsi di “accontentarli” in tutto (entro i limiti delle loro possibilità), di non far mancare loro niente ; ma spesso non si accorgono che con i figli non si può “vivere di solo pane”, perchè essi hanno soprattutto bisogno di un altro tipo di pane : quello dell’ascolto, del dialogo, della condivisione, del sostegno, della vicinanza, del cauto consiglio.
Penso che uno dei più grandi e benefici “segreti” di ogni educazione familiare sia racchiuso nella capacità che i genitori hanno di “crescere” essi stessi con i propri figli, accettando di essere bambini quando essi sono bambini, adolescenti quando essi lo sono, giovani quando essi lo diventano, e così via : come se ogni genitore tornasse a rinascere e a crescere a nuova vita attraverso il divenire dei propri figli. Solo in questo “immedesimarsi” sono racchiuse sia la possibilità di ascolto che di dialogo con essi.
Anche Michelangelo, forse, “ascoltava” i suoi marmi con amorevole intensità, cercando di cogliere la loro realtà più nascosta, prima che il suo “intelligente scalpello” iniziasse, con paziente e appassionata premura a “levare”da essi quelle forme sublimi che ancora oggi ci inondano con la loro travolgente, immortale Bellezza.
Parlare con mia figlia di queste meraviglie e vedere i suoi occhi incantevoli accendersi d’amore è stata una delle più stupende risposte a molte delle domande sulla mia identità di madre.