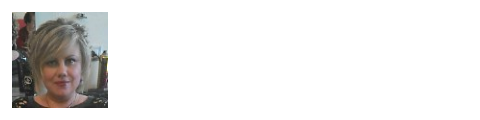Recentemente mi è accaduto di vedere un vecchio film del 1968, “Diario di una schizofrenica”, di Nelo Risi, liberamente tratto dall’omonimo libro della psichiatra svizzera Marguerite Andrée Secheaye, pubblicato dalla casa editrice Giunti di Firenze. Il film – uno dei rari film di contenuto psicoanalitico attendibili e particolarmente curati (il regista si avvalse della consulenza dello psicanalista Franco Fornari) – , narra la vicenda di una ragazza schizofrenica (Renée), la quale, dopo essere guarita dalla sua sofferenza a seguito delle cure amorevoli prestatele dalla sua analista, ripercorre in un diario tutto il suo vissuto di sofferenza fino alla riconquista della cosidetta “normalità”.
La vicenda cinematografica mette in particolare risalto anche la figura della terapeuta, la quale mai perse fiducia nella “umanità” profondissima che trapelava dalla propria paziente, al di là della sofferenza mentale e del disperato decadimento mentale ed emotivo che caratterizzava il suo comportamento.
E’ proprio da questa fiducia nutrita d’amore, da questo incrollabile riconoscimento della dignità umana della propria assistita che, nel film, come nel libro, si costruisce la lenta, ma esaltante guarigione della giovane Renée.
La visione di questo film mi ha intensamente coinvolta e mi ha indotta a formulare alcune riflessioni sul “mondo” apparentemente impenetrabile dell’umana sofferenza mentale.
Un mondo terribile, nel quale è rimasto prigioniero anche un mio intimo familiare, che ormai da anni sto seguendo con infinito amore.
Io penso che l’approccio alla malattia mentale richieda sempre un atto di coraggio, sostenuto da una carica di profondissima, amorevole umanità. Il coraggio è fondamentale per superare l’abisso dell’orrore che un primo impatto con il disturbo mentale può suscitare in ciascuno di noi. Colui che noi, persone “normali”, definiamo “pazzo”, ad un primo contatto ha il potere di scardinare tutte le nostre sicurezze logiche ed i nostri abituali sistemi di riferimento sui quali si appoggia la nostra percezione della realtà.
Dinanzi a questo “scempio” delle sicurezze logiche ed emotive, che alterano l’equilibrio “omeostatico” (cioè la tendenza alla stabilità) che caratterizza il nostro assetto psichico ed anche fisico, si attivano immediatamente meccanismi reattivi di difesa dell’Io, che inducono alla “fuga”, alla “negazione”, al “rifiuto”, fino a costituire una vera e propria barriera difensiva nei confronti del cosidetto “orrore della patologia”.
Molte persone – forse persino la maggior parte delle persone – non riescono mai a superare questo “promontorio della paura”, e finiscono con l’ “esorcizzare” la sofferenza mentale, considerandola, come facevano anche gli antichi, come una sorta di “possessione demoniaca”, da “rimuovere” dal proprio campo di coscienza.
Eppure, se con una scelta amorevole, corggiosa ed intrepida, proviamo ad accettare fino in fondo, senza spaventarsi, proprio quel sovvertimento del reale e della “normalità” che costituisce la trama della sofferenza mentale, gradatamente i vaneggiamenti deliranti della cosidetta “alienità” cominciano a svelarsi come espressione di un “mondo”.
Un mondo anche esso sostenuto da un “codice” in grado di possedere una propria “logica”, un proprio “sentire”, un proprio “provare emozioni”, un proprio “soffrire”, un proprio – persino – “sorridere”, un proprio “osservare”. Un mondo “diverso”, certamente, da quello della maggior parte delle persone, ma diverso soltanto perchè “meno diffuso”, più raro, meno praticato dai più, sicuramente da sostenere anche con interventi farmacologici, ma tuttavia “possibile”, perchè umano, profondamente umano.
La possibilità di vedere nella sofferenza mentale non un vuoto “salto nell’assurdo”, né una dissoluzione totale del senso della vita, ma un “mondo possibile” al quale restituire tutta la sua umanissima dignità, è stata una delle più grandi conquiste della Psicologia clinica e della Psichiatria del nostro tempo.
Il grande psichiatra svizzero Ludwig Binswanger ne è stato uno dei più grandi assertori e studiosi.
Mentre la psichiatria ufficiale e “accademica” tracciava una netta linea di demarcazione fra “sanità” e “follia”, considerando il “malato mentale” come una persona totalmente “out” rispetto alla maggior parte degli esseri umani, egli vide nella cosidetta “malattia mentale” non una “mostruosità” abnorme ed irrecuparabile, ma un “modo possibile di essere-nel-mondo”, cioè un modo particolare di vivere la realtà, diversa, sì, dai modi più correnti, ma non “fuori” da ogni realtà. In sostanza egli considerò il “malato mentale” come un uomo “portatore di storia”, cioè come una persona la cui storia personale, a seguito di circostanze endogene e esogene, aveva preso una certa “piega”, sfociando in una visione della vita contratta e povera di contenuti, oppure distaccata dalla realtà e orientata verso un mondo di fantasia, vissuto come sostitutivo rispetto a quello reale.
Per chi si accosta con rispetto alla sofferenza mentale, il pensiero di Binswanger può essere di profondo giovamento per “vedere” in una prospettiva più ricca di speranza e di umanità quella che la mentàlita’ comune considera come una sciagura senza rimedio, di cui vergognarsi.
“Antropoanlisi” è la denominazione che Binswanger volle dare alla sua teoria dell’uomo e della sofferenza mentale. Con questo termine egli indicò il nuovo compito che la psichiatria e la psicologia avrebbero dovuto svolgere nello studio della personalità umana : quello di individuare e descrivere innanzitutto i possibili modi di essere-nel-mondo da parte dell’uomo, ricavando da questo studio indicazioni del tutto nuove su come interpretare la sofferenza mentale, vedendola come espressione, anche essa, di un possibile modo di essere-nel-mondo.
La costruzione di questa teoria fu il prodotto di una geniale sintesi operata da Binswanger fra la Psichiatria e l’Esistenzialismo filosofico di Martin Heidegger. Infatti, la terminologia che egli usò fu desunta dalla filosofia esitenzialista, con lo scopo di restituire alla Psichiatria e alla Psicologia il compito di studiare l’uomo nella globalità della sua “presenza” nel mondo, evitando gli eccessivi riduzionismi delle scienze umane del suo tempo. Una “lezione” di vita e di scienza profondamente rispettosa della dignità umana, che, elaborata negli anni ‘30 e perfezionata nel dopoguerra, fino al 1966, anno della morte di Binswanger, conserva ancora oggi tutta la sua carica di attualità e di speranza nella dignità dell’uomo che soffre.