Introduzione
Recentemente mi è accaduto di leggere con molto interesse e partecipazione un libro che oserei definire “prezioso” per chi, come me, ama la Psicologia, ed in particolare è attratta dal misterioso mondo delle umane emozioni, sempre fervido di sorprendenti giochi di luci ed ombre. Si tratta del saggio di uno dei più eminenti psichiatri italiani, assai noto anche sul piano internazionale, scrittore suggestivo di molti libri di avvincente interesse : Vittorino Andreoli, “Un secolo di follia. Il Novecento fra terapia della parola e dei farmaci” (Milano, BUR, 1991, IV ediz. 2006).
Nel saggio, dopo un breve excursus sulla storia della follia dall’antichità fino al secolo XIX, l’autore muove dal lontano 1895, da quando, cioè, Sigmund Freud
pubblicò, con Joseph Breuer, i suoi famosi “Studi sull’isteria”, che gettarono le prime basi della Psicoanalisi come metodo terapeutico del tutto innovativo, fondato su una nuova visione dell’uomo sofferente, come “soggetto” da ascoltare e capire con amorevole cura e partecipazione e non più come “oggetto” privo di anima, da trattare come un “diverso”, un mostro scomodo, deviante da una norma precostituita, da segregare in un manicomio per lo più a vita.
Partendo da quella data, Andreoli segue, con passione e profonda cultura storica, il lento e graduale cammino della Psichiatria del Novecento verso una progressiva umanizzazione dell’approccio alla malattia mentale, caratterizzato da un sempre maggiore rispetto per la dolente umanità e dignità del “malato mentale”. In pagine veramente entusiasmanti egli descrive la progressiva collocazione delle sindromi patologiche più gravi – come, ad esempio, la schizofrenia, un tempo ritenuta irrimediabilmente inguaribile , e liquidata con l’infamante diagnosi di “dementia praecox” – , sullo sfondo di un nuovo orizzonte di speranza, animato dalla convinzione che anche la stessa malattia mentale, in quanto pur sempre “umana”, possa essere curata come qualunque altra “affezione” che può colpire l’uomo. Prospettiva, questa, che oggi a noi può apparire persino ovvia, ma che tuttavia ha richiesto molti anni di tormentato cammino, non solo di ricerca scientifica, ma anche di superamento di rigidi pregiudizi sociali che ancora, talvolta, non risultano del tutto scomparsi soprattutto dinanzi alle manifestazioni più “sconcertanti” del disagio mentale.
Ma un altro problema fondamentale sul quale il saggio di Andreoli si sofferma è quello dello stesso concetto di “cura”. Qui risalta maggiormente la sua profonda sensibilità di uomo e di professionista ben consapevole del fatto che entrare in rapporto terapeutico con una persona “folle” significa curare non soltanto una “malattia” astratta, individuata sulla base di parametri diagnostici statisticamente prefissati, ma, soprattutto, si tratta di curare un “malato”, cioè un uomo concreto, che vive la sua malattia “in corpore vivo”, cioè in un corpo vitale, che agisce immerso in un dinamico contesto di pensieri, di sentimenti, emozioni, aspirazioni, speranze maturate nel corso di un vissuto storico del tutto personale, collocato sempre in una determinata situazione ambientale.
La necessaria e imprescindibile considerazione di tutte queste variabili, secondo l’opinione di Andreoli, deve sempre accompagnare e orientare il “lavoro” dello psichiatra nella scelta del tipo di cura da adottare, sia in campo psicofarmacologico che in campo psicoterapeutico. In tal senso è necessario che il professionista autenticamente “serio” abbandoni ogni forma di astratto dogmatismo cattedratico, per cercare di cogliere il “senso” specifico della sofferenza mentale del “paziente”, per adeguarvi la cura più adatta, anche quando tale sofferenza sia determinata da cause prevalentemente biologiche. Persino in questo caso, infatti, vi sarà pur sempre una “equazione individuale”, tessuta di componenti storiche personali e ambientali, a far da cornice e da filtro alle predisposizioni biologiche.
Sulla base di queste considerazioni, Andreoli giunge alla conclusione che il vero “filo d’Arianna” che dovrebbe guidare metodologicamente il lavoro dello psichiatra non è soltanto la competenza professionale e la conoscenza e padronanza quanto più perfette possibili degli strumenti diagnostici e delle strategie di intervento più adatte a fronteggiare ogni forma di disagio mentale, ma anche il “dubbio”.
Per esistere come psichiatri autentici, una volta acquisite tutte le più solide certezze tecnico-professionali in grado di permettere di diagnosticare la “follia”, bisognerebbe poi avere il coraggio di dubitare sempre di tutto quando si entri in diretto contatto col “folle”. Questo perché la “follia” è e sempre sarà un “universale astratto “, mentre il “folle” – per dir tutto in termini aristotelici – è e sempre sarà un “accidente” rispetto ad ogni astrazione. L’universale lo inquadra, ma non ne esaurisce l’imprevedibilità. L’unica possibilità per confrontarsi con la concreta individualità del “folle” risiede paradossalmente nell’abbandonare il “camice” per immedesimarsi anche un solo attimo nella follia dell’altro. In tal senso, “credo che il dubbio sia il vero paradigma psichiatrico. Come psichiatra ho dubitato, spesso, d’essere io stesso folle, uno che cura l’altro curandosi. Chi è lo psichiatra? Se si dovesse presupporre uno psichiatra ‘sano di mente’ per curare il malato, non si sarebbe mai strutturata questa disciplina, per mancanza di psichiatri. Ma credo che un pazzo possa curare un altro pazzo e, dunque, che il ruolo sia legittimo”. (Andreoli, “Il dubbio nella psichiatria oggi”, in “Un secolo di follia.. ..”, cit., 2006).
È ovvio che Andreoli non stia parlando di psichiatri “matti da legare” come unici interlocutori possibili di altri “matti” ; ma in realtà voglia sollecitare molto più umanamente la necessità di un rapporto “empatico” fra psichiatra e paziente, dove anche lo psichiatra faccia leva sulla propria capacità di pensare in modo divergente rispetto alla “norma” (capacità peraltro presente in tutti noi, se pensiamo, ad esempio, al linguaggio dei nostri sogni o alle nostre fantasie ad occhi aperti), per “entrare” nel mondo della follia e coglierne il significato umano. Operazione o, per meglio dire, “esperienza”, questa, in grado di schiudere un universo di inaspettate sorprese, dove al linguaggio della follia viene restituita la “dignità” di pensiero possibile e, in casi estremi, anche geniale, ma degno sempre di essere ascoltato e compreso. Ciò non significa, ovviamente, ignorare tutti gli apparati diagnostici e soprattutto le terapie farmacologiche, psicoterapeutiche e riabilitative ; significa “comprendere”, prima di applicare cure, come spesso può accadere, sulla base di astratti paradigmi terapeutici esposti fatalmente al rischio dell’imprecisione, con grave danno per il paziente. In merito, così si esprime Andreoli : “Il dubbio diventa ancora più sostanziale quando i mezzi di intervento (terapie) sono imprecisi. Per togliere un pensiero delirante si cancella la possibilità di produrre qualsiasi pensiero ; per impedire un movimento si toglie la forza di compiere ogni possibile azione. Una modificazione per amputazione”. (cfr. ibid. cit.)
Da questa prospettiva, dove la cautela e il dubbio è giusto che sostituiscano l’accanimento terapeutico – specialmente quello fondato sulle cosiddette “terapie ad urto” (elettroshock, shock insulinico) – , per dar luogo ad una considerazione più “saggia” e più “pensosa” della follia, Andreoli, negli ultimi capitoli del suo saggio, sviluppa ulteriormente le sue riflessioni collocando doverosamente la Psichiatria sullo sfondo più generale delle rivoluzioni scientifiche ed epistemologiche che hanno caratterizzato il Novecento. Si tratta di tre capitoli di notevolissimo interesse : “Requiem per la Verità” ; “Bohu e Tohu o l’elogio del Caos” ; “Note, con personaggi, per la follia”.
Il Novecento è stato un secolo contrassegnato dal progressivo tramonto dell’orgoglio della Ragione umana di poter raggiungere Verità assolute in tutti i campi del Sapere e dell’Agire. Dall’Illuminismo settecentesco fino al Positivismo ottocentesco, tutto il pensiero filosofico, politico, economico, tecnologico, scientifico appare animato dalla grande speranza di poter pervenire alla costruzione di sistemi di verità, o di leggi scientifiche in grado di fornire spiegazioni assolute e definitive sulla Natura, sulla vita dell’uomo nel suo assetto psicologico, sociale, politico, economico, nonché sulla costituzione dell’intero Universo.
Il Novecento, devastato da due terribili Guerre Mondiali, con le loro immani carneficine (non bisogna mai dimenticarlo), a fronte di ogni dogmatismo assoluto, si propone, invece, come il secolo dell’incertezza, del bisogno di rivedere tutti i valori, da quelli morali, religiosi, politici, sociali, economici, a quelli scientifici, per saggiarne la presunta validità assoluta e contestarla, pervenendo in tutti i campi a dimostrare il relativismo di ogni nostra conoscenza. “La cultura oggi – osserva Andreoli – esalta l’incertezza, magnifica l’imperfezione, proclama il relativismo come paradigma di conoscenza…. Anche la Psicoanalisi è morta. Anch’essa, pur parlando del non-razionale, aveva generato un sistema razionale”. Oggi, la sicurezza assoluta di quel sistema è messa in dubbio, ad esempio, dall’Ermeneutica (interpretazione) , un indirizzo di pensiero proposto dal filosofo tedesco Hans Georg Gadamer (1900-2002), che ad ogni forma di assolutismo dogmatico contrappone il principio per cui ogni fenomeno può essere interpretato in modi sempre diversi e tutte le interpretazioni sono convenzionali come il linguaggio che le esprime. “La parola è uno strumento che può ingannare, tanto da dover interpretare il linguaggio prima di interpretare ciò che esso definisce. Insomma, si deve interpretare lo strumento con cui si interpreta.” (Andreoli, “Requiem per la Verità”, in “Un secolo di follia….”, cit.). All’Ermeneutica si aggiunge il “Falsificazionismo” del filosofo austriaco Karl Popper (1902-1994), per il quale “ogni risultato scientifico deve essere dubitabile e, dunque, imperfetto, punto di partenza di nuovi esperimenti per una progressiva, ma mai definitiva perfezione.” (ibid.).
A fianco di questo “nuovo scetticismo” nei confronti della metodologia scientifica tradizionale, si collocano anche i sorprendenti orizzonti di ricerca nel campo della Fisica, dove il diffondersi della teoria quantistica della materia, da Max Planck (1858-1947) in poi (il concetto di “quanto” fu introdotto da Planck nel 1900 e ripreso poi da Einstein nel 1905), ha profondamente modificato la visione “oggettiva” della realtà, fondata sulle leggi meccaniche stabilite da Galilei e Newton secondo precise formule matematiche di valore assoluto.
Alla visione tradizionale di un mondo congegnato come un orologio di precisione, dove particelle solide e indivisibili (atomi) interagiscono fra loro secondo nessi di causa-effetto rigorosamente misurabili, la teoria quantistica ha contrapposto una nuova concezione della materia composta da particelle subatomiche, da concepirsi come minuscoli concentrati (o “pacchetti”) di energia, detti “quanti”, che hanno una natura fondamentalmente ondulatoria, cioè emanano onde energetiche che possono propagarsi secondo infinite possibilità, assumendo una struttura definita solo quando cerchiamo di misurarle. Questo significa che siamo noi a dare una struttura all’universo, di cui peraltro facciamo parte, e non l’Universo ad essere strutturato in sé, indipendentemente da noi. Ad una visione del reale dominata dalla assoluta necessità logico-matematica, la teoria quantistica della materia ha contrapposto una nuova visione fondata sull’infinitezza del possibile. La classica dialettica fra le “particelle solide” e il vuoto che le contiene viene sostituita dal nuovo concetto di “campo di energia”, dove il vuoto (cioè il biblico “bohu-tohu” ) non è più “uno stato di semplice non-essere, ma contiene la potenzialità di tutte le forme del mondo”, alle quali siamo noi, con i nostri strumenti di misura, a dare corpo e a influenzarle, poiché noi stessi siamo composti di quanti e i quanti, come centri di energia, si influenzano a vicenda, alla luce di infinite possibilità.
A questo punto, se nulla è più necessario, ma tutto diviene possibile, anche ” la percezione della follia…. richiama la ‘incertezza fondamentale’ dei fisici, in cui l’atomo non è più atomo, il vuoto non è più vuoto, la certezza è indeterminatezza, lo spazio è indistinguibile dal tempo. Follia e normalità non devono, forse, più porsi come due termini distinti, analogamente a vuoto e pieno, bensì in un insieme che ha tolto senso specifico ai suoi termini. La follia è forse piena di normalità e la normalità trabocca di follia” (cfr. “Bohu e Tohu, o l’elogio del Caos”, in “Un secolo di follia….”, cit.).
Forse, quando, all’età di cinquanta anni, Don Alfonso Chisciano decide di diventare cavaliere errante col nome di Don Chisciotte della Mancia, come narra Cervantes, per viaggiare per il mondo “a proteggere coloro che poco valgono, vendicare quei che ricevono torti e punire perfidie”, scontrandosi con mostri, negromanti, incantesimi, mulini a vento ed altre diavolerie, la sua è vera follia? Don Chisciotte, per l’attuale diagnostica sarebbe affetto da una forma di “parafrenia fantastica”. Una schizofrenia di tipo “nucleare”, cioè limitata, che si esprime solo su un tema (in questo caso l’illusione di essere cavaliere errante) e lascia libera e lucida la mente quando essa si occupa di ogni altra questione (infatti tutti ammiravano la saggezza di Don Chisciotte quando egli discuteva di ogni argomento che non riguardasse la cavalleria). Forse per Don Chisciotte “importante è convincersi d’essere qualcuno, altrimenti non è possibile essere. Con una identità si acquisisce un dovere e Don Chisciotte ha scelto con la follia l’etica più umana possibile : difendere i deboli e fare giustizia dove c’è sopraffazione. La follia è l’unico campo in cui sono ancora possibili ideali. Nel concreto, tutto diventa scontato e banale. Anche se il banale viene visto (dal curato, dal barbiere, dall’oste e dal canonico) come saggezza” (cfr. “Note, con personaggi, per la follia d’un nuovo secolo. Don Chisciotte della Mancia, ovvero Alfonso Chisciano”, in “Un secolo di follia….”, cit.). Indubbiamente, Don Chisciotte, come “parafrenico” deve essere curato. Ma fino a che punto? Quale dovrebbe essere l’atteggiamento migliore da adottare nei suoi confronti, da parte dello psichiatra? Anche lo psichiatra in fondo è un po’ un “Don Chisciotte”. Anche lui, se è autentico, cerca di difendere i deboli e gli emarginati, e in tal senso “deve” essere anche lui un po’ folle, o almeno capace di immedesimarsi nella “follia del folle” . Allora, in nome di una astratta “normalità”, dovrà interrompere brutalmente il “sogno” del Don Chisciotte-paziente, cancellandolo e riportando la personalità di quel “malato” nel grigiore della quotidiana banalità, oppure con amorevole rispetto dovrà aiutare quell’uomo (non più quel malato!) a tornare a dialogare con la vita reale, senza fargli perdere il senso della bellezza e del profondo valore etico del suo sogno? Un dilemma che indubbiamente valica i confini della semplice rivisitazione letteraria del mitico personaggio di Miguel Cervantes, per avviare una profondissima e sempre necessaria riflessione sulla Psichiatria e sulla figura dello psichiatra.
L’originalità del saggio di Andreoli, e soprattutto il suo vibrante messaggio di umanità, risiede proprio in questa conclusione “aperta al possibile”, come accade nella fisica quantistica.
A me, avida e appassionata lettrice, è sembrato di leggervi, in particolare, un invito ad affiancare l’amore ad ogni programma terapeutico nei confronti del disagio mentale. E subito mi è tornato in mente un film stupendo, che mi è accaduto di vedere e rivedere più volte con sempre rinnovata passione e intenso interesse : “A Beautiful Mind”. Un film che molti conosceranno, ma che non perde mai il suo fascino profondo ad ogni “rilettura”.
Un film amaro e sconcertante per il “caso” di follia di cui tratta, ma che diviene esaltante e commovente per l’offerta d’amore da parte di una donna : un’offerta appassionata, coraggiosa, sconfinata e senza riserve, che in modo inarrestabile e quasi travolgente aiuta il protagonista a prendere le distanze dalla propria follia, più – quasi – di quanto non abbiano fatto sia le cure ad urto, sia le cure psicofarmacologiche cui egli è stato sottoposto. L’amore lo salva e, soprattutto, aiuta la sua “mente meravigliosa” a conservarsi integra, al punto da meritare i premi Nobel e Abel.
Inizialmente, le pesantissime cure farmacologiche e ad urto (shock insulinico), miranti soltanto a riportarlo alla “normalità”, lo devastano e mettono a repentaglio la sua mente e la sua personalità. Solo quando esse vengono “rimodellate”, coniugandosi con l’amore, e, soprattutto, “calandosi” nella essenza più profonda, unica e irripetibile, della sua personalità, il protagonista “rinasce” a nuova vita e la sua follia si trasforma in una nuova saggezza : ed è qui che si svela tutta la potente forza del richiamo ad una psichiatria più attenta ai valori umani e individuali, che abbiamo seguito percorrendo l’entusiasmante saggio di Andreoli.
Approccio introduttivo al film “A Beautiful Mind”
Con queste note, mi propongo, ora, di sviluppare una analisi del film” A beautiful Mind”, con una breve riflessione sul tema della “schizofrenia paranoide” che viene trattato nella fiction cinematografica, dove la sindrome in oggetto è efficacemente e realisticamente rappresentata nello stile di vita, nel pensiero e nelle azioni del personaggio protagonista.
Il film (U.S.A., 2001, Premio Oscar miglior film 2002) è del regista Ron Howard (Premio Oscar migliore regia 2002). Esso è dedicato alla vita del Prof. John Forbes Nash jr. (Bluefield, 1928 – Monroe, 2015), grande matematico, Premio Nobel per l’Economia nel 1994 e Premio Abel nel 2015, la cui figura è magistralmente interpretata dall’attore neozelandese Russell Crowe (Golden Globe 2002).
Nella elaborazione del film, il regista si è liberamente ispirato alla biografia dello scienziato, scritta dalla giornalista e scrittrice Sylvia Nasar (“A Beautiful Mind. The life of Matematical Genius and Nobel Laureate John Nash”, Simon & Schuster Paperbacks, New York, 1998. Traduz. italiana di C. Caparano, R. Zuppet, S. Mancini, col titolo “Il genio dei numeri. A Beautiful Mind”, Milano, Rizzoli, 1999, VI ediz. BUR Scienza, 2006).
Cenni essenziali sulla vita reale di John Nash, per meglio comprendere il film
Nella vita reale, John Nash, tragicamente scomparso in un incidente
stradale il 23 Maggio 2015, assieme alla moglie Alicia, è
stato uno dei più geniali matematici ed economisti del Novecento. I
suoi studi di Matematica applicata alla “Teoria dei giochi” (nel cui
ambito è rimasta famosa la sua “Teoria dell’equilibrio di Nash”) furono
veramente rivoluzionari, fino a fargli ottenere, nel 1994, il Premio
Nobel per l’Economia. Ma anche in Matematica pura egli realizzò
importantissime scoperte, trovando soluzioni sorprendenti in campo
algebrico, nel campo delle equazioni e in quello della Meccanica
Quantistica, fino a meritare il prestigioso Abel Prize, destinato
annualmente dal re di Norvegia al migliore matematico straniero del
mondo (per la cronaca, egli ebbe l’incidente mortale proprio mentre
era di ritorno a casa in taxi, dall’aeroporto di Newark, N.J., dopo
aver ritirato il premio in Norvegia).
Tuttavia, se egli fu uno scienziato veramente geniale, la sua
personalità dovette drammaticamente confrontarsi anche con un
ricorrente disturbo mentale di notevole gravità, che lo tormentò per
quasi un trentennio (dal 1959, quando ne comparvero i primi chiari
sintomi, fino a quasi tutti gli anni ’80), con un andamento ciclico,
dove si alternavano periodi di lucidità mentale, anche lunghi, e
brusche ricadute nella malattia.
Questo disturbo mentale fu diagnosticato come “schizofrenia
paranoide”, e compromise per molti anni la sua carriera universitaria
e la sua vita coniugale e relazionale.
Quando iniziò questo suo “calvario”, egli si era già distinto da
alcuni anni per la sua genialità, in un primo tempo presso
l’Università Carnegie Mellon di Pittsburgh, dove, nel 1948, aveva
conseguito la laurea in Matematica. Poi, ottenuta una prestigiosa
borsa di studio per un PhD (Dottorato di ricerca), aveva manifestato le sue geniali qualità
presso l’Università di Princeton, dove in quegli anni insegnavano
scienziati famosissimi come Albert Einstein e John von Neumann. Qui
egli aveva nutrito intensamente, quasi al limite dell’ossessione,
l’idea di trovare una teoria originale che potesse renderlo famoso, e
nel 1949, a conclusione di un continuo lavoro di ricerca, quando
ancora non aveva concluso il suo PhD, era pervenuto a stabilire quelle
rivoluzionarie regole matematiche nella “Teoria dei giochi”, di cui
abbiamo parlato, descrivendole nella sua tesi di dottorato, destinata
a divenire un testo scientifico famoso, che, 45 anni dopo, avrebbe
fatto conseguire a Nash, assieme ad altre sue scoperte, il Premio
Nobel per l’Economia.
Conseguito il PhD, nel 1951 egli era entrato nel M.I.T. (Massachusets
Institut of Technology, Cambridge Massachusets), dove aveva proseguito
le sue ricerche, occupandosi in particolare di questioni relative alla
Meccanica Quantistica e tenendo lezioni di Matematica pura e
applicata. Nel frattempo, nel corso di un suo ciclo di lezioni, aveva
conosciuto Alicia Larde, una studentessa di Fisica che si era
innamorata di lui e che nel 1957 sarebbe divenuta sua moglie. Essa,
come vedremo anche nel film, avrebbe avuto nella vita di Nash una
importanza notevolissima.
La sua carriera si stava costruendo in modo assai brillante, malgrado
certe “anomalie” del suo carattere, molto solitario, aggressivo,
scontroso e difficile sul piano dei rapporti interpersonali, quando,
nel 1959, era “esplosa” in modo inequivocabile la sua malattia
mentale.
Essa si manifestò il giorno in cui Nash, tenendo in mano una copia del
New York Times, ritenne di dovere informare tutti i colleghi del
M.I.T., presenti nella sala insegnanti, che un articolo del giornale
conteneva un messaggio cifrato di Alieni di un’altra Galassia, che
solo lui era in grado di leggere. Superata,da parte dei colleghi, la
prima impressione che egli stesse scherzando, apparve ben presto
chiaro che si trattava, invece, di una forma di delirio allucinatorio,
rientrante, come poi fu diagnosticato, nel quadro della “schizofrenia
paranoide”.
Da quel momento prese inizio l’interminabile fase della vita di
Nash, in cui egli sarebbe stato tormentato ciclicamente dalla sua
malattia, durante la quale si resero necessari ben cinque ricoveri in
varie cliniche psichiatriche, con terapie farmacologiche che spesso
furono integrate da somministrazioni di shock insulinico. Alcuni di
questi ricoveri furono coatti, e comportarono, soprattutto dopo il
secondo ricovero, una rottura di rapporti con la moglie, alla quale
Nash non perdonò di avere firmato il TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio). La rottura, malgrado la
presenza di un figlio, si concluse con un divorzio. Ma il distacco non
fu mai definitivo, perché Alicia amava molto il marito e continuò sempre ad interessarsi di lui, fino a che, negli anni’70, i due si risposarono e da quel momento Alicia assistette ancor più
amorevolmente Nash, sostenendolo nei momenti più drammatici, fino ad
aiutarlo, assieme ad altri colleghi che furono molto disponibili, a
“guarire”, a riprendere l’insegnamento all’Università di Princeton,
all’inizio degli anni ’90, fino al conseguimento del Nobel Prize e
poi, infine, al conseguimento dell’altro prestigioso Abel Prize 2015,
poco prima della morte.
Quadro clinico della schizofrenia, con particolare riferimento alla
sindrome paranoide
Le presenti note sono state desunte dai seguenti testi :
– Silvano Arieti, “Interpretation of Schizophrenia”, New York, Basic
Books, 1974 (trad. it.,“Interpretazione della schizofrenia”, Milano,
Feltrinelli, 1978, nuova ediz. aggiornata, Roma, L’Asino d’oro
edizioni, 2014)
– William Harris, “Signal & Symptoms of Schizophrenia”, Alvis Ed.,
2012 (trad. it., “I sintomi della schizofrenia”, Alvis, 2012)
– DSM IV e DSM 5, “Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders”, APA, American Psychiatric Association. Ed. IV, 1994-2000 ;
ed. 5, 2013. (Traduzioni italiane : “Manuale Diagnostico e Statistico
dei Disturbi Mentali”, ed. IV, Milano, Masson, 1996-2004 ; ed. 5,
Milano, Raffaello Cortina Editore, 2014)
– ICD-10 (“International Classification of Diseases”, chap. V, sect.
F20, World Health Organisation-OMS, (Traduzione italiana
:“Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei
Problemi Sanitari Correlati”, a cura del Ministero della Salute,
aggiorn. 2013)
Definizione di “Schizofrenia”
La schizofrenia (dal greco antico “schizo”, verbo che significa
“separare” + “fren”= cervello, quindi : “separazione del cervello”) è
un grave disturbo psicotico a carattere “dissociativo”, in grado di
determinare notevoli disfunzioni in diverse aree primarie della
personalità umana, come quelle del pensiero, della percezione,
dell’attenzione, delle emozioni, dell”affettività, delle relazioni
sociali, del comportamento motorio.
Disturbo psicotico
Per disturbo psicotico, o psicosi, si intende un tipo di sofferenza
mentale che, con vari gradi di intensità e durata, può determinare una
alterazione o una perdita del senso della realtà, con bruschi
cambiamenti di umore e con l’insorgere di idee anomale. In tale stato
psichico, le funzioni mentali che guidano la vita quotidiana diventano
confuse, perdono coerenza o consistenza logica e producono false
convinzioni o false interpretazioni di fatti o eventi della normale
routine di tutti i giorni.
Questa visione alterata della realtà è accompagnata per lo più da
notevoli cambiamenti del tono dell’umore, improntati spesso ad
angoscia, attacchi di panico, isolamento di tipo autistico, oppure ad
aggressività e a manifestazioni di sprezzante e ostentata superiorità,
caratterizzata da comportamenti bizzarri e maniacali. Essa culmina
spesso in varie forme di delirio e di allucinazione.
Delirio
Per “delirio” (dal latino “lira”=solco + “de”=da, preposizione che
indica allontanamento, per cui delirare significa “uscire dal solco”,
cioè, in senso figurato, “dalla via della ragione”) si intende una
convinzione o una idea errata, che viene acquisita come vera e
sostenuta in modo rigido contro qualunque richiamo al buon senso, la
quale altera la percezione mentale della realtà (tale è, nel film, la
convinzione patologica del protagonista che vi sia in atto un
complotto di spie russe contro gli Stati Uniti, che egli deve aiutare
a smascherare decifrando messaggi segreti).
Allucinazione
Per “allucinazione” (dal verbo greco antico ”haluskein”=fuggire,
scappare ; oppure, meglio, dal verbo latino “alucinari”, che contiene
la radice della parola “lux”=luce, =abbagliare, abbacinare, nel senso
di “alterare la facoltà visiva”) si intende una falsa percezione in
assenza di uno stimolo esterno reale (spesso si usa definire
l’allucinazione anche come “percezione senza oggetto”).Questo disturbo
si verifica quando la persona in stato di psicosi vede, sente, odora o
prova stimoli che nella realtà non esistono, come, ad esempio udire
voci che nessuna persona riesce ad udire, oppure vedere cose, persone
ed altro, del tutto inesistenti su di un piano di realtà (come accade
al protagonista del film, che vede e ascolta personaggi immaginari,
con i quali interagisce, vivendo con loro una vicenda anche essa del
tutto immaginaria).
La schizofrenia vera e propria
Esistono molte tipologie di psicosi, variamente graduate per livello
di gravità e di durata nel tempo. La schizofrenia è la forma di
psicosi sicuramente più grave, più strutturata e di più lunga durata.
Essa, data la sua complessità, è andata soggetta a diverse forme di
classificazione, spesso contrassegnate da discussioni e valutazioni
critiche di vario orientamento. In questa sede, per non addentrarsi su
terreni scarsamente attinenti alla finalità del presente lavoro, che
ha uno scopo soltanto informativo, ho deciso di seguire i suggerimenti
dei testi che ho citato prima.
Sintomi e tipologie di Schizofrenia
Il DSM IV (cit.) descrive cinque tipologie fondamentali di
schizofrenia in base alle diverse sintomatologie : la schizofrenia
disorganizzata (F20.2 nell’ICD 10, cit.), quella catatonica (F20.2
nell’ICD 10, cit.), quella paranoide, (F20.0 nell’ICD 10, cit.),
quella indifferenziata (F20.3 nell’ICD, cit.), quella residua (F20.5
nell’ICD 10, cit.) suddividendone i sintomi generali in positivi e
negativi.
(Deve essere doverosamente sottolineato, però, che il DSM 5, pur non
escludendo questa classificazione di fondo, ne scoraggia l’uso
eccessivamente rigido, preferendo privilegiare una “lettura” della
schizofrenia in termini di “spettro”, cioè sistema o raggio di segnali
che presentano delle affinità (infatti la sezione dedicata alla
schizofrenia è introdotta col nuovo titolo “Schizophrenia spectrum and
other psychotic disorders”, in italiano : “Disturbo dello spettro
della schizofrenia e altri disturbi psicotici”), per dare maggior peso
alla presenza di alcuni sintomi “positivi”, come deliri e allucinazioni,
o “negativi”, come diminuzione dell’espressione delle emozioni o abulia,
eloquio disorganizzato, comportamento catatonico. Secondo il DSM 5,
si potrebbe parlare di Schizofrenia se almeno due o più dei sintomi di
cui sopra risultassero presenti per un periodo di tempo di almeno un
mese, assumendo quindi caratteristiche significative. In questa sede,
comunque, pur tenendo presenti anche le proposte del DSM 5, ci
atterremo, a scopo di maggiore precisione descrittiva, alla
classificazione più tradizionale, peraltro ancora in uso, e,
soprattutto, usata ai tempi dei disturbi mentali di John Nash).
I sintomi positivi della schizofrenia
I sintomi positivi, comprendono i deliri e le allucinazioni e si
presentano quando la persona ha perduto i contatto con la realtà in
misura rilevante. Qui l’aggettivo “positivo”non viene usato nel senso
di “buono”, ma viene utilizzato per designare sintomi che si
“pongono”, cioè di “propongono”, si “manifestano” senza un riferimento
reale sensato e oggettivo.
I deliri, a esempio, possono portare lo schizofrenico a credere che
gli altri leggano nei suoi pensieri o complottino contro di lui (come
nel film), oppure lo controllino segretamente in vari modi ; in certi
casi può credere di essere lui stesso a controllare e interpretare la
mente altrui.
Le allucinazioni portano invece lo schizofrenico a sentire e vedere
cose o anche persone nella realtà inesistenti, con le quali soltanto
lui, di fatto, entra in contatto. Fra queste distorsioni, le più
frequenti sono quelle di tipo uditivo, come sentire voci inesistenti ;
ma non mancano anche quelle di tipo visivo, come vedere qualcuno o
qualcosa che non esiste nella realtà (nel film sono presenti ambedue i
tipi di allucinazione).
Questa sintomatologia può essere talvolta accompagnata anche da certi
eccessi, come un modo disorganizzato di parlare, spesso
incomprensibile per l’ascoltatore, unitamente a molti comportamenti
bizzarri che alterano o impediscono una normale vita sociale (anche il
protagonista del film manifesta atteggiamenti del genere).
I sintomi negativi della schizofrenia
I sintomi negativi consistono nella assenza, o forte impoverimento, di
molte caratteristiche della personalità che, sia pure in modo vario da
individuo a individuo, dovrebbero essere normalmente presenti nella
vita di ognuno, come l’affettività, la capacità di provare sentimenti,
emozioni, entusiasmi, curiosità, interessi e altro. Il profilo
caratteriale del soggetto schizofrenico presenta, invece, gravi
deficit comportamentali, come – generalmente – l’abulia (o anche
apatia), la alogia, l’anedonia, la asocialità e la anaffettività.
* La abulia (dal greco antico “a”= prefisso che indica mancanza,
assenza + “boulé”= volontà ; quindi : “mancanza di volontà”), oppure,
anche, apatia (dal greco antico “a”= prefisso che indica mancanza +
“pathos”= emozione ; quindi : “mancanza di emozioni”) è una forma di
“pigrizia” accompagnata da scarso o assente interesse per le consuete
attività quotidiane, da quelle che riguardano l’igiene e il decoro
personale a quelle che riguardano le attività lavorative, scolastiche
o domestiche.
* La alogia (dal greco antico “a”= prefisso che indica mancanza +
“logos”= discorso, linguaggio ; quindi : “mancanza di linguaggio”, nel
senso di “povertà di linguaggio”) è un disturbo che riguarda il
linguaggio, caratterizzato da scarsità o mancanza di comunicazione,
oppure da povertà di contenuti, che appaiono vaghi e ripetitivi.
* la anedonia (dal greco antico “an”= prefisso negativo che indica
mancanza + “edoné = piacere ; quindi : “mancanza di piacere”) è una
perdita di interesse o di entusiasmo per le attività ricreative,
sociali e anche sessuali (il protagonista del film ne soffre in
parte).
* La asocialità riguarda l’area dei rapporti interpersonali, dove i
soggetti schizofrenici presentano gravi deficit, essendo poco
interessati a stare con la gente, avendo spesso problemi di
comunicazione corretta e comprensibile, vivendo prevalentemente in
solitudine, muovendosi lentamente e isolandosi, con ripetizione
ossessiva di gesti ritmici, quali camminare come robot, dondolarsi a
anche camminare in circolo (questi atteggiamenti sono vissuti in toto
dal protagonista del film, ivi comprese le abitudini motorie, dove, ad
esempio spiccano non soltanto la sua andatura sempre incerta, ma anche
la ripetizione motoriav ossessiva che egli pratica in bicicletta
manovrando le ruote in modo che disegnino il segno dell’infinito).
* La anaffettività, da intendersi come mancanza di sentimenti,
freddezza o assenza di “calore” emotivo, è caratterizzata da un senso
diffuso di lontananza, distacco e interesse verso qualsiasi legame
profondo con persone reali. Lo schizofrenico che presenta questo
sintomo negativo non riesce in genere a provare forti emozioni, né
positive né negative e manifesta un “appiattimento emotivo”, dovuto
forse ad una sua incapacità a riconoscere le proprie emozioni e quelle
degli altri. In tal senso, tende a isolarsi, ad affrontare i problemi
sempre da solo, oppure a mantenere con gli altri solo relazioni
formali e superficiali, le quali spesso – specie nella schizofrenia
paranoide – possono essere condizionate da una notevole diffidenza e
dall’ansia intensa di “essere controllati” (anche il protagonista del
film si presenta con queste caratteristiche, specialmente nella prima
parte della fiction. Successivamente la sua rigidità si addolcisce
quando incontra Alicia, pur permanendo in lui i deliri e le
allucinazioni).
Tutta questa complessa sintomatologia, non è detto che debba essere
presente “in toto” quando si deve diagnosticare una schizofrenia. Ma
quando buona parte, oppure la maggior parte dei sintomi sopra
descritti si connettono fra loro per formare un insieme strutturato,
che si ripete e si mantiene con notevole costanza nel tempo (in genere
da uno a sei mesi dopo il primo episodio), allora si deve parlare non
più di semplice “episodio” psicotico, ma di una vera e propria
“sindrome schizofrenica”, dove la parola “sindrome” (dal greco antico
“sun”, preposizione che significa “con” + “dromos” = “corsa”, dal
verbo “draomai”= “correre” ; quindi : “correre insieme”, “correre
con”) vuole indicare un “concorso di sintomi” in grado di permettere
una diagnosi di malattia.
Descrizione delle tipologie di schizofrenia che interessano il film e
il suo protagonista
Come sopra detto, il DSM distingue e descrive classicamente cinque tipi di
schizofrenia : quella disorganizzata, quella catatonica, quella
paranoide, quella indifferenziata e quella residua. In questa sede,
riporteremo cenni sulle prime tre sindromi, per soffermarci
maggiormente sulla terza, che interessa più direttamente il
personaggio protagonista del film, anche se nel suo comportamento non
mancano tratti che rientrano nelle altre due sindromi.
a) Nella tipologia “disorganizzata” compaiono e prevalgono soprattutto
disturbi nell’area cognitiva, che possono prendere la forma di veri e
propri deficit neurocognitivi, con indebolimento di alcune funzioni di
base, quali la capacità di comprendere, la memoria, il giudizio,
l’attenzione, la concentrazione, la risoluzione di problemi, la
funzione esecutiva, la comprensione del senso della vita quotidiana,
sia a livello emozionale, sia a livello organizzativo. Si tratta di
una forma di schizofrenia caratterizzata da pensieri, parole e comportamenti
che sono inappropriati o non hanno senso e che rendono assai problematico persino
lo svolgimento delle attività quotidiane. Un tempo questo tipo di schizofrenia
era anche definita “ebefrenica” (da Ebe, dea della gioventù nella mitologia greca),
perché prevalentemente presente nei giovani, o adolescenti ; comunque, può
essere presente anche negli adulti, con caratteri regressivi.
(Anche il protagonista del film presenta qualche tratto ebefrenico
dopo avere subito le prime terapie “ad urto” – shock insulinico -)
b) Nella tipologia “catatonica” (dalla preposizione greca antica
“katà” = “giù” + “tonos”= “tensione”, nel senso di “caduta di
tensione”), i sintomi più evidenti sono quelli riguardanti l’attività
motoria, dove la schizofrenia è caratterizzata da stati di totale
immobilità fisica, che possono anche alternarsi a stati di forte e
incontrollata eccitazione convulsiva. I catatonici in genere non
riescono a rispondere alle istruzioni e spesso i loro arti si
presentano rigidi e affetti da gonfiore quando sono in stato di
passiva immobilità ; oppure sono agitati da una iperattività
disordinata, che li porta a camminare avanti e indietro, senza una
precisa méta (queste ultime caratteristiche affliggono spesso il
protagonista del film specie quando si trova alla ossessiva ricerca di
una teoria geniale). Lo stato di passività è normalmente accompagnato
da un linguaggio di tipo meccanico e inerziale, col quale, come in un
effetto eco, vengono ripetute parole o frasi pronunciate da altre
persone. Nello stato di eccitamento, invece, il catatonico può
mettersi a gridare e parlare in modo incessante e incoerente,
pronunciando frasi incomprensibili (questo sintomo si manifesta nel
protagonista, quando egli, soprattutto nella terza parte del film,
cerca di scacciare i personaggi delle sue allucinazioni).
c) Nella schizofrenia “paranoide” (dalla preposizione greca antica
“parà”= “presso”, nel senso di “approssimazione”, “approssimativo”+
“nous”= “mente”, quindi : “mente approssimativa”, cioè “anomala”,
“folle”), il sintomo predominante è la presenza dei deliri. Quelli di
persecuzione, cioè relativi alla sensazione di sentirsi al centro di
complotti, sono i più frequenti ; ma spesso queste forme deliranti
sono accompagnate anche da deliri di grandezza, di onnipotenza, nei
quali lo schizofrenico ostenta un senso esagerato della propria
importanza, della propria superiorità sugli altri, della propria
intelligenza e della propria “genialità” nel vedere e intuire cose o
soluzioni che gli altri, nella loro pochezza, non riescono a cogliere.
E proprio per questo “titanismo solitario”, magari, si sente
insidiato, spiato, calunniato, controllato e perseguitato dagli altri
e dal mondo intero.
Con i deliri si intrecciano anche le allucinazioni. Le più frequenti
possono essere quelle uditive, durante le quali la persona sente voci
inesistenti, oppure riferisce a se stessa frammenti di conversazioni
altrui, ascoltate per caso. Abbastanza ricorrenti, però, possono
essere anche le allucinazioni visive, nelle quali lo schizofrenico
vede personaggi immaginari – che per lui sono del tutto reali -, con i
quali entra in contatto e dialoga ; oppure attribuisce significati
persecutori a circostanze, eventi o persone che rientrano nella vita
comune di ogni giorno. Ad esempio, una persona che può accadere di
incrociare spesso , perché abitante nel medesimo quartiere, viene
vista come la spia di un’organizzazione segreta, oppure ciò che viene
letto nei giornali contiene messaggi criptati di carattere
persecutorio, personali oppure diretti all’intera Umanità.
Questa mania di persecuzione, si inquadra, poi, nel contesto di un
carattere agitato, polemico, irascibile e talvolta violento, dove le
difficoltà di comunicazione con gli altri risultano estremamente
complicate, anche perché il soggetto schizofrenico è portato a credere
fermamente nella realtà dei propri deliri e delle proprie
allucinazioni, e qualunque richiamo al senso di realtà viene
interpretato come una sorta di perfida astuzia o di malevolo inganno
ordito nei suoi confronti da parte di chi sta congiurando contro di
lui. In tal senso, l’acquisizione di un maggiore senso critico o di un
certo grado di consapevolezza sulla natura illusoria delle proprie
fantasie costituisce il primo, importante “scoglio” da superare per
potere inoltrarsi sulla strada più confortante di un possibile ritorno
alla realtà e alla “normalità” (tutte le caratteristiche sopra
esposte, che intervengono nello scenario della schizofrenia paranoide,
sono presenti “in toto” nella vita del protagonista del film, compreso
lo sforzo finale che egli compie, con successo, di assumere una nuova
consapevolezza critica dei propri deliri e delle proprie
allucinazioni. Uno sforzo sostenuto dall’amore che la moglie Alicia
nutre nei suoi confronti e dalla disponibilità affettuosa di alcuni
colleghi, che si conclude in una straordinaria forma di “guarigione”,
premiata dal Nobel).
Analisi del film “A Beautiful Mind”
Il film può essere suddiviso in tre parti, abbastanza nettamente
distinte fra loro, ma armoniosamente “concertanti”, come tre movimenti
di una sinfonia.
Nella prima parte l’azione scenica descrive la realtà come viene
vissuta in prima persona da John Nash. Si tratta di una realtà
costituita da uno scenario universitario (Princeton), dove si
sviluppano situazioni e si muovono persone con le quali il
protagonista interagisce con la parola, col pensiero, con il proprio
stile di vita, con le caratteristiche della propria personalità, anche
se questa, peraltro, appare già piuttosto bizzarra, scontrosa,
solitaria, sospettosa, ambiziosa, assai competitiva, ossessivamente
“in cerca di gloria”, ma geniale, creativa e tutto sommato ancora, sia
pure approssimativamente, “nella norma”. Tutto, in questa prima parte
del film, si svolge come una storia interessante e reale. Quando le
geniali scoperte che Nash ha compiuto nel campo della Matematica
applicata alla teoria dei giochi, storicamente effettive, ed il suo
successivo impiego presso il M.I.T., anche esso reale – abbellito
dalla grande svolta del suo incontro con Alicia -, determinano un suo
“ingaggio” nei Servizi Segreti dello Stato come decifratore di codici,
tale evento appare, o può apparire, del tutto plausibile ed in
sintonia col clima storico del “maccartismo” diffuso negli anni ’50
negli Stati Uniti.
Nella seconda parte del film, però, si svela improvvisamente, in un
drammatico susseguirsi di colpi di scena, un agghiacciante e
sconvolgente scenario di ambiguo intreccio fra realtà, delirio e
allucinazione, che per anni si è insinuato nella vita del
protagonista. Ciò che prima appariva come realtà accettabile si
destabilizza improvvisamente e, guardato dall’esterno – non più dal
punto di vista del protagonista – diventa follia, deformazione,
perdita di senso, come in un quadro surreale. E’ un momento
particolarmente intenso ed emozionante per lo spettatore. Ma proprio
qui è racchiuso il “pathos” affascinante del film. Alcuni dei
personaggi con i quali il protagonista interagiva risultano del tutto
immaginari, come altrettanto immaginaria e frutto di una vera e
propria sindrome delirante di tipo persecutorio si rivela il
coinvolgimento di Nash nei Servizi Segreti di Stato. Tutto si
sconvolge e si disperde in una dimensione vaga, oscillante fra sogno e
realtà.
Ma quando tutto sembra frammentarsi e dileguarsi nel grigiore di una
follia senza speranza, dove le terapie farmacologiche e quelle “ad
urto” sono soltanto inesorabili condanne a vita, ecco che la terza
parte del film, strettamente connessa con la seconda, descrive il
lento, graduale percorso che il protagonista segue verso la
“guarigione”, sostenuto e confortato dal profondo amore della moglie
Alicia. Questo “cammino della speranza” inizia quando egli,
finalmente, comincia a comprendere criticamente la natura illusoria
dei propri deliri allucinatori e dei personaggi immaginari che vi
hanno “abitato”, e riprende lentamente e “umilmente” contatto con la
realtà, aiutato, oltre che dalla moglie, anche da alcuni colleghi che
un tempo egli aveva considerato come fastidiosi, invidiosi e rivali, i
quali ora, invece, si svelano ai suoi occhi non più allucinati, come
amici sinceri, che hanno sempre apprezzato la sua genialità. In questo
nuovo clima di amore e di amicizia, il protagonista del film è come se
“rinascesse” : riprende contatto con l’Università, con l’insegnamento
e infine il suo antico “sogno di gloria” si avvera e culmina con il
Premio Nobel, che gli viene conferito in un clima di intensa,
affettuosa commozione.
Trama del film
Il film inizia nel 1948, quando John Nash, già laureato in Matematica,
entra all’Università di Princeton per conseguire il PhD, come
vincitore della prestigiosa borsa di studio della Carnegie Foundation
for the Advancement of Teaching. Egli è un giovane ventenne molto
ambizioso, narcisista, tendenzialmente solitario e refrattario ai
rapporti sociali. Ascolta, sedendo in disparte, il discorso di
accoglienza che il Rettore dell’Università rivolge a tutti gli
studenti, incitandoli ad essere la gloria degli Stati Uniti come lo
sono stati i loro predecessori, i quali, durante la Seconda Guerra
Mondiale, sono riusciti, con la loro intelligenza matematica, a
decifrare i codici segreti giapponesi. Adesso si tratta di contrastare
il nuovo pericolo rappresentato dall’Unione Sovietica, che vuole
instaurare nel mondo il Comunismo Globale mediante i suoi servizi
segreti. Chi sarà fra loro il nuovo genio, come Einstein e altri?
Nash è desideroso di distinguersi nel campo della Matematica ed è
sempre immerso nei suoi calcoli, alla ricerca di una teoria originale,
che possa renderlo famoso. Egli guarda con invidia, ma anche con
disprezzo, gli altri colleghi, specialmente quelli che hanno già delle
pubblicazioni, ritenendoli inferiori a sé. Fra questi, spicca quello
che egli considera il suo principale rivale, Martin Hansen, di cui
egli demolisce rabbiosamente gli scritti.
Il suo comportamento goffo, bizzarro, taciturno e solitario, che si
manifesta fin dall’inizio del film, strappa le risate dei colleghi,
con a capo lo stesso Martin Hansen, i quali spesso lo prendono in
giro, considerandolo un po’ “diverso” e facendogli degli scherzi, come
quando, nella caffetteria del Campus, distogliendolo da una partita a
biliardo che egli sta giocando in tutta solitudine, contro se stesso,
lo incitano a farsi avanti per conquistare una ragazza (d’accordo con
loro), deridendo il suo misero fallimento e la sua mancanza di tatto,
causato della sua grottesca goffaggine emozionale.
Il suo desiderio di emergere rimane inizialmente frustrato : egli
studia, ha tante idee, ma non riesce ad organizzarle per costruire una
teoria. Quando egli cerca di convincere il Rettore a dargli un
incarico o a fargli incontrare Einstein, il Professore lo mette
dinanzi alla sua mancanza di “produttività” scientifica, sottolineando
che tutti gli altri studenti hanno già pubblicato qualcosa, mentre lui
non è riuscito a tirar fuori nulla di originale, e lo accusa di
mancare di obbiettivi specifici. Con l’occasione, lo fa assistere ad
una cerimonia, nella quale un Professore, nella caffetteria destinata
ai docenti, riceve in regalo una penna da parte di ciascuno dei
colleghi presenti, come riconoscimento simbolico della sua carriera,
del suo valore e della sua costanza nel porsi e nel raggiungere degli
obbiettivi scientifici. Finché Nash non farà altrettanto e,
soprattutto, non sarà più umile e meno arrogante, disertando le
lezioni, da lui ritenute “inutili”, egli sarà destinato al fallimento.
A questo punto la solitudine e la puntigliosità di Nash nel volere
essere a tutti i costi originale raggiunge il massimo livello. L’unica
persona con la quale egli stabilisce un rapporto di amicizia è il suo
compagno di stanza, Charles Herman, che lo ascolta, spesso lo segue e
mostra di comprenderlo, venendo accolto e tollerato da Nash con
discreta disponibilità.
Una sera, però, sempre nella caffetteria del Campus, mentre Nash si
trova seduto ad un tavolo con i colleghi, l’attenzione generale viene
attratta dall’ingresso di una ragazza bionda, assai bella,
accompagnata da quattro amiche, graziose, ma non di spicco come la
ragazza bionda. Subito tutti gli studenti decidono di farsi avanti per
conquistare la ragazza più bella, e Martin Hansen ricorda a tutti il
principio della “libera concorrenza” di Adam Smith, in base al quale
“l’ambizione individuale serve al bene comune” (cioè produce e
incrementa la ricchezza delle Nazioni). Quindi, “vinca il migliore” e
i perdenti, eventualmente, si consoleranno con le altre quattro
ragazze. A questo punto, fra la sorpresa di tutti, interviene Nash
affermando che il principio di Adam Smith deve essere rivisto. Se
tutti concentrassero la propria attenzione sulla ragazza bionda, non è
detto che alla ragazza piaccia qualcuno dei “concorrenti”, per cui
tutti rischierebbero di rimanere perdenti. Se poi i perdenti
rivolgessero la propria attenzione sulle amiche della ragazza,
rischierebbero di perdere nuovamente, perché potrebbe essere probabile
che a nessuna di quelle ragazze piaccia essere di ripiego. In questo
modo, la competizione “cieca” ed esclusivamente individuale non
produrrebbe alcun risultato apprezzabile, perché tutti finirebbero con
l’ostacolarsi a vicenda, perdendo. Per evitare questo rischio,
occorrerebbe che ciascuno rinunciasse a corteggiare la ragazza bionda,
accettando di corteggiare soltanto le altre amiche. Solo in questo
modo, rinunciando a qualcosa, tutti potrebbero vincitori. Se Adam
Smith sosteneva che il miglior risultato si ottiene quando ogni
componente di un gruppo concorrenziale agisce cercando individualmente
il meglio per sé, tale principio deve essere modificato. Il miglior
risultato si otterrà, invece, quando ogni componente del gruppo farà
ciò che è meglio per sé e per il gruppo stesso.
Muovendo da questa semplice, ma geniale intuizione, Nash costruisce la
sua “Teoria dell’equilibrio” applicata ai “Giochi strategici” e
all’Economia, e la espone nella sua tesi per il PhD, che lo rende in
breve tempo famoso e getta le prime, lontane basi del suo futuro
Premio Nobel.
Dopo questo primo successo, la carriera di Nash decolla rapidamente.
Egli si inserisce nel M.I.T (Massachusetts Institut of Technology),
dove lavora con due colleghi (Sol e Bender). Il suo genio matematico
trova ulteriori conferme ed egli tiene anche lezioni di Matematica per
studenti specializzandi, sia pure di malavoglia.
A questo punto, la sua fama ormai consolidata lo porta, un giorno, ad
essere contattato dal Pentagono, dove, per la sua incredibile capacità
matematica, viene introdotto in una stanza segreta di decrittazione,
con l’invito a decifrare il significato di una serie di numeri
trasmessi da una radio di Mosca che si sospetta contengano dei codici
destinati ad agenti segreti russi che vogliono introdursi negli Stati
Uniti a scopo di spionaggio (non si deve dimenticare che in quegli
anni ’50 era in pieno sviluppo la cosiddetta “Guerra Fredda” fra
Occidente a Oriente, ed in particolare fra gli Stati Uniti e
l’U.R.S.S.). Nash, con il semplice uso della memoria, individua in
breve tempo il senso di alcune serie numeriche, che corrispondono alle
coordinate geografiche di due località americane da dove
presumibilmente gli agenti russi cercheranno di entrare negli Stati
Uniti.
Questa sua geniale capacità, una sera lo porta ad essere ulteriormente
contattato da un ufficiale del Dipartimento della Difesa, da lui già
intravisto durante la prima esperienza al Pentagono. Questa persona è
William Parcher, il quale gli affida una missione altamente “Top
Secret”, che consisterà nello scoprire dove un gruppo terroristico
sovietico collocherà una bomba atomica da far scoppiare sul suolo
degli U.S.A.. Siccome i membri di questo gruppo comunicano fra loro
mediante messaggi criptici mascherati negli articoli di numerosi
magazine, compito di Nash dovrà essere quello di leggere attentamente
tutti i testi di questi giornali, cercando di individuare i messaggi.
Tali messaggi, una volta decriptati, dovranno essere collocati in una
busta e segretamente inseriti, a mano, di notte, nella cassetta
postale di una villa dove hanno una loro sede i servizi segreti del
Dipartimento della Difesa. Per aprire questa cassetta postale, egli
dovrà esporre il proprio polso a un lettore magnetico. A questo
proposito, sul suo polso viene inserito un microchip sottocutaneo, al
termine di una visita ad un capannone situato vicino all’Università,
apparentemente abbandonato, ma sorvegliato e anche esso sede di
laboratori dei Servizi segreti. Nash dovrà mantenere il più rigoroso
silenzio su questa sua missione e dovrà guardarsi dalle spie russe,
che sicuramente potrebbero essere in agguato dovunque.
Nel frattempo, egli incontra Alicia Larde, giovane studentessa di
Fisica, che si innamora di lui e che per la prima volta risveglia in
lui un sentimento d’amore, fino a spingerlo ad innamorarsi a sua volta
di lei.
Dopo avere ricevuto l’incarico di controspionaggio, Nash adibisce il
suo ufficio al MIT a centro di raccolta e di studio dei magazine che
William Parcher gli ha indicato, ed esegue regolarmente le consegne
dei messaggi decriptati, inserendoli di notte nella cassetta postale.
In questa fase della sua attività ritorna a frequentarlo il suo
compagno di stanza Charles Herman, che per un certo tempo era rimasto
assente, il quale, questa volta ha con sé la nipotina Marcee, affidata
alle sue cure perché rimasta orfana di ambedue i genitori, morti in un
incidente stradale.
In parallelo a questi avvenimenti, la relazione affettiva fra Nash e
Alicia prosegue positivamente, ed essi decidono di sposarsi, anche se
William Parcher, che sorveglia sempre Nash, non vede di buon occhio il
matrimonio, perché la missione che Nash deve eseguire sarebbe più
adatta ad un single. E la cosa si complica ulteriormente quando Alicia
aspetta un bambino.
Una sera, mentre Nash colloca nella consueta cassetta postale il plico
con i messaggi decriptati, Parcher, agitatissimo, lo avvicina, lo fa
salire nella sua auto e lo avverte che le spie russe hanno scoperto la
sua attività e lo stanno inseguendo per ucciderlo. Segue un drammatico
inseguimento fra auto, con una sparatoria dalla quale Parcher e Nash
riescono ad uscire vivi per miracolo.
Dopo questo episodio, Nash torna a casa sconvolto e in pieno attacco
di panico. Si chiude nella propria stanza, rifiutandosi inizialmente
di rispondere alle domande disperate di Alicia. Infine le rivela di
essere inseguito da spie russe e dal suo linguaggio alterato e
incerto, Alicia, mettendo insieme altri segnali di stranezze che già
Nash aveva cominciato a manifestare sempre più insistentemente, inizia
a capire che forse egli è “ammalato” e decide di aiutarlo, informando
lo psichiatra Dr. Rosen e autorizzandolo a curare il marito anche in
modo coatto, se necessario.
Qui inizia la seconda sorprendente parte del film, dove la malattia di
Nash ormai diviene manifesta.
Il giorno dopo, Nash, in una scena particolarmente drammatica manifesta
apertamente in pubblico la sua follia quando, mentre sta insegnando,
vede dei “Russi” che, come egli pensa, lo hanno pedinato e lo accerchiano
da tutte le parti. Essi, capeggiati da un “sedicente” Dr. Rosen, lo
“catturano” per ricoverarlo nell’Ospedale Psichiatrico McArthur.
Il Dr. Rosen, dai discorsi slegati e farneticanti di Nash, capisce
innanzitutto che Charles e la nipotina, a cui il suo paziente fa
continuo riferimento, sono un’allucinazione visiva, e tramite una
telefonata all’Università di Princeton ne trova conferma, perché gli
viene detto che John Nash non ha mai avuto un compagno di stanza e,
per di più, nessuno ha mai conosciuto un Charles Herman. Anche Alicia,
nel frattempo, viene sollecitata dal Dr. Rosen a controllare se esista
veramente un William Parcher e un ufficio del Dipartimento della
Difesa nella villa dove Nash deponeva i suoi plichi.
Alicia si reca al M.I.T e, aiutata dai due colleghi collaboratori di
Nash, Sol e Bender, scopre l’allucinante verità che l’ufficio dove
Nash trascorreva in tutta segretezza tante ore del suo tempo è
tappezzato interamente da ritagli di giornali, accumulati in totale
disordine. Per di più, scopre che la villa del presunto Dipartimento
della Difesa è da lungo tempo disabitata e che la cassetta postale è
piena dei plichi ivi deposti da Nash, che, ovviamente, nessuno ha mai
ritirato.
Sulla base di tutti questi indizi, anche il presunto “complotto” delle
spie russe si svela del tutto immaginario, e a Nash, a questo punto,
viene diagnosticata una grave forma di “schizofrenia paranoide”. Sia
il Dr. Rosen che Alicia stessa cercano di rendere consapevole il
“malato” che non solo non esiste alcuna cospirazione, ma che anche
Charles, la nipotina Marcee e William Parcher a loro volta non
esistono e sono soltanto proiezioni della sua mente.
Nash rimane sconvolto, si agita, si rifiuta inizialmente di accettare
queste verità e pensa sempre ad un “complotto” nei suoi confronti, ma
poi cerca di controllare se esista veramente il microchip sottocutaneo
che Parcher gli aveva fatto inserire nel polso e si ferisce
inutilmente constatando che l’impianto non c’è. A quel punto egli
accetta di farsi curare, e la terapia a cui viene sottoposto è di tipo
farmacologico (gli vengono somministrate massicce dosi di torazina),
integrata da numerose sedute di shock insulinico.
Grazie a queste cure e all’amore di Alicia, Nash migliora e le sue
fantasie sembrano scomparire. Egli viene dimesso dall’Ospedale, ma è
fortemente scosso, intontito soprattutto dalla terapia ad urto che ha
subito, ed in lieve stato “catatonico”. Nel frattempo, egli è
diventato anche padre, ma trova difficoltà a prendersi cura del figlio
Johnny. Alla fine, per uscire da questa situazione di inerzia emotiva,
decide in segreto di non prendere più gli psicofarmaci, nella
convinzione che questa scelta lo porterà a ragionare meglio e magari
gli potrà permettere di essere reintegrato a Princeton.
La sospensione della cura, però, è totalmente negativa. Ben presto
ricompaiono i deliri persecutori e le allucinazioni uditive e visive,
e soprattutto ricompare William Parcher che gli suggerisce di
riprendere l’attività di decrittazione, utilizzando come nuovo ufficio
un capanno del giardino di casa.
Per un certo tempo Nash si dedica nuovamente a questo lavoro in grande
segretezza, fino a che il suo delirio allucinatorio dilaga in tutta la
sua gravità.
In una scena altamente drammatica e sconvolgente, egli, incaricato un
giorno da Alicia di fare il bagnetto al figlio, rischia di fare
annegare il bambino lasciandolo sotto l’acqua corrente nella
convinzione di averlo affidato temporaneamente a William Parcher,
mentre egli controlla dalla finestra se vi siano delle spie russe in
agguato. Alicia, che nel frattempo si trova in giardino mentre si
prepara un temporale, attirata per curiosità dal capanno dove spesso
Nash si ritira, decide di entrarvi e scopre al suo interno tutti i
ritagli di giornali intuendo subito che nuovamente il marito è
ricaduto nella sua malattia. Come spinta da un presentimento, si
precipita in casa e salva appena in tempo il bambino dall’annegamento,
mentre Nash cerca di convincerla che il bambino era al sicuro perché
era affidato a William Parcher. bAlicia, terrorizzata, decide di
telefonare al Dr. Rosen, ma William Parcher impone a Nash di
ucciderla, poiché la telefonata è sicuramente diretta alle spie russe
di cui Alicia è complice. Alla scena è presente a questo punto anche
Charles con la nipotina, e anche egli suggerisce a Nash di eseguire
l’ordine di Parcher. Siccome Nash esita, allora Parcher tira fuori la
pistola per eseguire lui la sentenza, ma Nash, in un ultimo barlume di
coscienza, si getta contro Parcher per impedire l’omicidio e fa cadere
Alicia col bambino. Alicia che ha seguito tutti i dialoghi deliranti
di Nash con personaggi del tutto immaginari che lei, ovviamente, non
vede, decide di fuggire in auto col bambino, sotto la pioggia. Nash,
però, la ferma e le dice, disperato, che forse tutto è veramente
un’illusione, perché, soprattutto, ha compreso che la nipotina di
Charles, dopo tanto tempo trascorso, “non cresce mai”.
In quel momento è come se Nash, pur nella sua schizofrenia, avesse
acquisito finalmente una coscienza critica nei confronti del proprio
delirio e delle proprie allucinazioni.
Questa è l’inizio della “svolta” che apre la terza parte del film,
quella che avvierà Nash sulla via della sua “guarigione”.
Alicia, commossa dalle parole del marito, rinuncia a partire e
rinuncia anche a sottoscrivere un suo nuovo ricovero coatto, malgrado
che il Dr. Rosen suggerisca di riprendere tutto il programma
terapeutico già sperimentato. Ella decide, invece, di aderire all’idea
del marito di usare la forza critica della mente come terapia
fondamentale per “guarire” dalla malattia. E questa forza sarà
confortata e potenziata soprattutto dall’amore, perché, come lei
stessa suggerisce al marito in un dialogo assai intenso e commovente,
la mente da sola non basterà mai per affrontare le insidie della vita.
Ci vuole anche il cuore, cioè la potenza dell’amore.
Nash, sostenuto dall’amore di Alicia e dalla propria intelligenza e
volontà, decide di ripresentarsi con umiltà a Princeton, dopo che sono
trascorsi ormai tanti anni, superando la vergogna della sua malattia,
che lo ha trasformato anche dal punto di vista fisico e motorio,
rendendo la sua andatura incerta e vacillante, e resistendo anche agli
atteggiamenti di disprezzo di alcuni studenti che si fanno beffe di
lui e lo scimmiottano. Qui egli trova come nuovo Rettore il suo antico
collega-rivale Martin Hansen, che lo accoglie con affettuosa,
amichevole benevolenza e commosso rispetto, permettendogli di
frequentare nuovamente il Campus, destinandogli un posto in
Biblioteca, dove Nash potrà riprendere i suoi studi, e comprendendolo
con grandissima sensibilità quando Nash, in certi giorni, è in preda
alle sue crisi deliranti e lotta contro le proprie allucinazioni
gridando disperatamente che sono inesistenti.
Lentamente Nash riprende le sue ricerche scientifiche, frequenta come
“studente” i corsi di Princeton, poi torna ad essere reintegrato nel
suo PhD, fino a che Martin Hansen, che lo ha aiutato in modo
determinante a riconquistare una sua dignità di uomo e di studioso,
gli conferisce un incarico di Docente di Matematica. La sua attività
di ricerca scientifica riprende in pieno, in modo molto produttivo, la
sua genialità si risveglia ed egli torna nuovamente ad essere famoso,
riscuotendo consensi e un nuovo generale rispetto.
Un giorno un collega gli comunica che il suo nome è stato candidato
per il Premio Nobel. Nash, in tutta la sua ritrovata umiltà, rimane
incredulo, quasi non ritenendosi all’altezza di questo altissimo
riconoscimento. Ma il collega lo invita a prendere un the nella
caffetteria dei docenti, e lì, con sua immensa sorpresa e intensissima
commozione, tutti gli altri colleghi presenti si accostano a turno al
suo tavolo e depongono, ciascuno, dinanzi a lui, una penna, come
riconoscimento rispettoso dei suoi meriti. Anche egli, adesso, dopo
tanti anni di sofferenze, ha finalmente raggiunto l’obbiettivo della
sua vita, come gli aveva suggerito di fare il vecchio Rettore nella
prima parte del film facendolo assistere ad una analoga cerimonia.
Adesso, di quella cerimonia egli è il nuovo dignitoso e ammirato
protagonista.
Il film si conclude con il toccante discorso che Nash pronuncia in
occasione del Premio Nobel per l’Economia, che gli viene conferito nel
1994. Egli dedica il premio alla moglie Alicia, che col suo amorevole
sostegno gli ha permesso di raggiungere questa méta e di scoprire,
soprattutto, che dopo tante ricerche logiche, matematiche, fisiche e
metafisiche, l’unica equazione che conta nella vita è quella
dell’amore.
Mentre egli esce con la moglie dal palazzo della cerimonia, i tre
personaggi della sua fantasia, uno accanto all’altro, lo osservano e
cercano di attirare la sua attenzione, ma Nash, ormai, non li prende
più in considerazione. Si può dire, a questo punto, che egli sia
“guarito” : non con la scomparsa totale delle sue allucinazioni, ma
imparando a distinguere criticamente la fantasia dalla realtà.
I sintomi della malattia di John Nash nel film e nella realtá
Le allucinazioni di Nash descritte nel film sono rappresentate dai tre personaggi immaginari con i quali egli interagisce come se fossero persone reali : Charles Herman, la nipotina di Charles, Marcee Herman, William Parcher.
Il delirio paranoide strutturato è costituito dal complotto dello spionaggio sovietico contro gli Stati Uniti d’America, per contrastare il quale Nash deve aiutare William Parcher, ufficiale del Dipartimento della Difesa. Tale delirio si inquadra nel clima “maccartista” realmente diffuso negli Stati Uniti negli anni ’50, caratterizzato da una eccessiva paura del Comunismo.
Nella realtà il delirio persecutorio di Iohn Nash fu un poco diverso. La sua schizofrenia paranoide si manifestava mediante una forma di delirio di onnipotenza, nel quale Nash si considerava alternativamente Imperatore dell’Antartide, oppure Profeta di Dio, o, ancora, capo di un Governo Universale. Inoltre egli era convinto di ricevere messaggi criptati, alternativamente, da alieni o da spie russe, che soltanto lui era in grado di interpretare.
Non risulta che i suoi deliri fossero accompagnati da specifiche allucinazioni uditive o, soprattutto, visive.
Nel film, l’introduzione dei tre personaggi immaginari, con l’illusione della loro effettiva realtà, è probabilmente un espediente scelto dal regista per “catturare” in modo avvincente l’attenzione dello spettatore, mediante un clima di “suspense”, al quale poi subentra in modo del tutto imprevisto il “trauma” della sorpresa, con la conseguente irruzione di una “dissonanza” cognitiva ed emotiva, che impone una brusca “ricomposizione” del campo di coscienza dello spettatore, obbligandolo a una nuova “lettura” dei personaggi e delle vicende nel cui ambito essi si muovono.
Questa “dissonanza” è probabilmente analoga a ciò che si può provare nella realtá dinanzi allo svelarsi improvviso di un sintomo schizoide, oppure di una vera e propria sindrome delirante, che si presenta inizialmente con connotati rigorosamente e formalmente logici, ma, come dinanzi ad un guscio apparentemente integro, ma vuoto, si scopre poi che manca di contenuto reale. Tutta la sapiente sceneggiatura del film concorre a determinare realisticamente questa sensazione, che ha il fortissimo potere di coinvolgere lo spettatore, facendogli percorrere una vera e propria “tastiera” emozionale.
Inizialmente, infatti, prevale la curiosità e la partecipazione nei confronti della vicenda biografica del protagonista, un po’ strano, ma geniale e destinato a diventare famoso.
In un secondo momento il coinvolgimento diviene più intenso e palpitante quando il film si “mette in movimento” e assume un ritmo poliziesco, da film di spionaggio, dove lo spettatore si identifica positivamente con il protagonista – eroe.
Poi, ecco, bruscamente, sopravvenire il trauma emotivo conseguente alla scoperta della natura delirante e malata dell’eroe. A questo punto, l’eroe “senza macchia e senza paura” diviene mostruoso, traditore, deturpato dalla pazzia e la prima reazione è di orrore, repulsione, allontanamento. “Per fortuna io non sono come lui. Io sono ‘normale’. Lui è un ‘diverso’. È un vero scandalo. È bene internarlo in manicomio” : questi sono approssimativamente alcuni dei pensieri che lo spettatore può essere stimolato a formulare. E sono pensieri realisticamente possibili dinanzi alla malattia mentale, che, quando si manifesta, mette in subbuglio tutta la nostra quotidiana sicurezza logica, creando un’ansia intensissima, insopportabile, come dinanzi ad un terremoto che rende improvvisamente instabile la statica degli edifici dove abitualmente si risiede. La prima impressione è che a questa mostruosità mentale non possa esserci alcun rimedio.
Ma non è questa la conclusione amara a cui il regista e il suo film vogliono pervenire. Dopo il trauma e il “lutto” per la misera caduta dell’eroe, il regista conduce abilmente lo spettatore verso un nuovo orizzonte emotivo. Quello della “umanizzazione” della sofferenza del protagonista. Dopo l’orrore nei confronti della patologia, che raggiunge il suo punto culminante quando John Nash, dietro la spinta delle sue fantasie allucinatorie, giunge quasi ad uccidere la moglie e il figlio, il protagonista torna improvvisamente ad essere “uomo”, ed in lui si risveglia il senso critico della razionalità, che gli permette di cominciare a prendere coscienza della inesistenza dei personaggi del suo delirio allucinatorio (la bambina non cresce mai!). In questa scena culminante, di alta intensità emotiva, è come se egli si “purificasse” dalla bruttura della sua folle tentazione animalesca e non è forse casuale che quando egli rivela questa sua nuova consapevolezza alla moglie, la scena si svolga sotto la pioggia come simbolo di purificazione. È un momento-svolta, che permette allo spettatore di ricomporre l’iniziale smarrimento dinanzi al “mostro”, avviandolo verso una nuova, inaspettata direzione emotiva, dove l’orrore si trasforma in “empatia”, cioè in una forma del tutto nuova di partecipazione alla malattia mentale del protagonista.
Egli, nel suo sforzo umanissimo di riemergere dal buio della sua perdizione, riconquista ancora più intensamente di prima l’amore della moglie. Lei lo spingerà a “guarire”, cioè a convivere in un modo del tutto nuovo, più umano , con la propria malattia, alla luce di una nuova “sinergia”, dove lo sforzo mentale per acquisire una definitiva consapevolezza critica verso le proprie allucinazioni si coniugherà con la forza appassionata dell’amore, in una nuova, potentissima e sorprendente “alleanza terapeutica”, in grado di trasformare il “mostro” in un personaggio degno del Premio Nobel : un uomo veramente degno della propria “Beautiful Mind”.
Prospettive terapeutiche sulla schizofrenia
Per molti anni, e forse ancora oggi, la schizofrenia è stata considerata una malattia incurabile e senza speranza di guarigione, perché tendente a cronicizzarsi e a degenerare. Non è casuale che alla fine dell’Ottocento si usasse l’espressione latina “dementia praecox”, coniata dallo psichiatra tedesco Emil Kraepelin (1856-1926) per designare il suo carattere degenerativo rispetto alle funzioni mentali. Anche se il grande psichiatra svizzero Eugen Bleuler (1857-1939) nel 1908-1911 aveva profondamente modificato il profilo descrittivo del disturbo psicotico precisandone meglio i connotati mediante l’introduzione del concetto di “schizofrenia” per sottolineare lo specifico aspetto “dissociativo” della malattia (Arieti, 1974, Berrios 2011, Berrios and oth., 2003), il pregiudizio sulla sua incurabilità è rimasto stabile per lungo tempo, come le terapie a carattere prevalentemente “aggressivo” (elettroshock e shock insulinico), miranti soltanto a mitigarne l’impatto (Arieti, 1979).
Oggi, l’introduzione di nuovi psicofarmaci antipsicotici e la possibilità. di integrare la terapia farmacologica con la psicoterapia individuale e di gruppo, hanno permesso di aprire nuove prospettive di “curabilità” della schizofrenia, anche se la possibilità di una “guarigione” totale da essa è oggetto di dibattiti e ricerche ancora in atto (Weiden and oth., 1994, 2006, 2007).
Già Silvano Arieti nel 1974 aveva parlato della necessità di ampliare l’orizzonte terapeutico della schizofrenia. integrando la somministrazione di psicofarmaci con la psicoterapia e manifestando personalmente qualche maggiore preferenza per il trattamento psicoterapico (Arieti, 1974).
I suoi preziosi suggerimenti trovano oggi un’eco favorevole nell’idea che lo schizofrenico, anche senza raggiungere una completa guarigione, possa reintegrarsi nella vita familiare, sociale, lavorativa e anche affettiva, mediante un opportuno programma terapeutico di équipe, in cui il paziente, la sua famiglia, lo psichiatra stesso, lo psicoterapeuta e i tecnici della riabilitazione lavorio insieme per permettere che la vita di ogni persona psicotica sia sempre più vicina a quella che noi definiamo “normalità”.
Questi sono i propositi programmatici formulati, ad esempio, in questi ultimi anni dal Prof. Peter J. Weiden, Direttore del programma per la cura degli psicotici presso l’Università dell’Illinois e il Chicago Medical Center (Weiden and oth., 1994, 2006, 2007).
In sostanza, se allo stato attuale delle ricerche, è ancora difficile che lo schizofrenico possa cancellare del tutto la sua malattia, sarà pur sempre possibile che egli possa imparare a “convivere” con i propri sintomi in un clima terapeutico improntato ad armonia collaborativa, disponibilità e amorevole accoglienza. Un po’ come accade nel film che ho esaminato e anche in un libro che mi è accaduto di leggere recentemente con molto interesse e commozione, scritto nel 1994 dalla psichiatra svizzera (di Ginevra) , Marguerite A. Sechehaye, “Diario di una schizofrenica”, dove mi ha particolarmente colpito l’amore, la disponibilità e la fiducia che la psichiatra non ha mai perduto verso l’umanità profondissima della propria paziente, che trapelava al di là della sua sofferenza mentale e del disperato degrado mentale ed emotivo che caratterizzava il suo comportamento. È proprio da questa fiducia nutrita d’amore, da questo incrollabile riconoscimento della dignità umana della propria assistita che in questo libro si costruisce la lenta, ma esaltante guarigione della giovane Renée. Anche in questo caso, l’amore, coniugato con le terapie, è stato uno degli ingredienti risolutivi per potere uscire dalla follia.
Bibliografia
Andreoli, V. (1991). “Un secolo di follia. Il Novecento fra terapia della parola e dei farmaci”, Milano, Rizzoli, IV edizione : 2012
Arieti, S. (1974). “Interpretation of Schizophrenia”, New York, Basic Books (traduz. italiana : “Interpretazioni della schizofrenia”, Milano, Feltrinelli, 1978 ; nuova ediz.agg., Roma, L’Asino d’oro edizioni, 2014)
Arieti, S. (1979). “Understanding and Helping the Schizophrenia”, New York,Basic Books
Berrios, G. E. (2011). “Eugen Bleuler’s Place in the History of Psichiatry”.Schizophrenia Bulletin 37 (6) : 1095-1098
Berrios, G. E., Luque, R., Villagran, J. M. (2003). “Schizophrenia : a conceptualhistory”. International Journal of Psychology and Psychological Therapy nol. 2 : 111-140
DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), IV (1994),5 (2013), A. P. A. (American Psychiatric Association). (traduz. italiane : DSM IV : “Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, Milano, Masson, 1996-2004 ; DSM 5 : Milano, Raffaello Cortina Editore, 2014)
Harris, W. (2012). “Signal & Symptoms of Schizophrenia”, Alvis International Editions (traduz. italiana : “I sintomi della schizofrenia”, Alvis Ed., 2012)
Harris, W. (2012). “Therapy of Schizophrenia”, Alvis International Editions
ICD 10 (International Classification of Diseases (chapt.V, sect. F20), World Health Organisation-OMS, 1994 (traduz. italiana : “Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati”, Ministero della Salute, aggiorn. 2013)
Sechehaye, M. (1955). “Diario di una schizofrenica”, Firenze, Giunti (nuova edizione : 2008)
Turkington, D., Kingdon D., Weiden, P. J. (2006). “Cognitive Behavioral Therapy for Schizophrenia”. American Journal of Psichiatry 163 : 365-373
Weiden, P. J., Havens, L. L. (1994). “Psycotherapeutic Management in the Treatment of Outpatiens with Schizophrenia”. Hospital and Community Psichiatry 45 : 549-555
Weiden, P. J., Preskorn, S., Fahnstock, P, Carpenter, D., Ross, R., Docherty, J.(2007). “Translating the Psychopharmacology of Antipsychotics to Individualized Traitment of a Severe Mental Illness : a Roadmap”, Special Issue of Journal of Clinical Psychiatry, 68 (Suppl. 7), 1-44
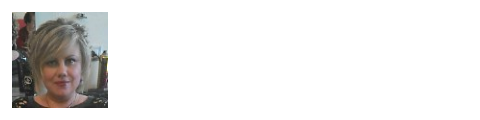

One thought on “Follia, genialità e amore nel film “A Beautiful Mind””
I like this post, enjoyed this one thank you for putting up. No man is wise enough by himself. by Titus Maccius Plautus. kfffeebeacdgekbe