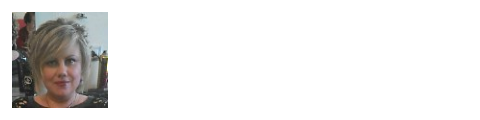Ogni giorno un uccello trovava requie sui rami secchi di un albero solitario in mezzo a una pianura desertica. Un giorno passò proprio là una tromba d’aria che coi suoi fulmini incenerì quell’albero. L’uccello fu costretto a volare a lungo. Alla fine, spossato, giunse in una foresta di alberi carichi di frutti. È una mamma che sta leggendo questa favola a un suo bambino, mentre viaggiano di fronte a me su un treno da Roma a Firenze. La morale non è più di tanto esaltante: è quella dell’adagio secondo il quale «non tutti i mali vengono per nuocere».
Ma io provo a pensare a qualcos’altro, lasciandomi condurre anch’io dal fascino dell’ascolto di una voce di madre: quell’uccello non avrebbe mai rinunciato alle sue abitudini, alla sicurezza e alla modestia di un’esistenza monotona, se non ci fosse stata quella bufera e quella perdita a prima vista devastante. La tempesta può generare lo scotimento dell’inerzia, fa imboccare il rischio, lasciando alle spalle la routine, la dipendenza e l’assuefazione. È l’aprirsi di un orizzonte inatteso e inaspettato. Nei suoi Colloqui, il grande umanista Erasmo da Rotterdam portava alle estreme conseguenze questa idea: «Non vi è nulla di così assurdo che l’abitudine non renda accettabile». Certo, c’è anche l’aspetto positivo della forza di sopportazione dei mali che l’assuefazione produce.
Ma l’elemento più pericoloso che trascina in sé è quello dell’accettazione, della caduta del desiderio di cercare qualcosa di più alto, è il non sospettare che ci sono mete più grandiose da conquistare. Infrangere i fili che legano piedi e mani e avviarsi in un lungo cammino è più faticoso di quanto s’immagini, tant’è vero che lo scrittore francese Courteline scherzava dicendo che «si cambia più facilmente la religione che il caffè»!(Ravasi)
Elogio dell’abitudine o contestazione dell’abitudine? Come sarebbe la nostra vita se non ci fossero le abitudini? Dinanzi alla vita e alle sue difficoltà, saremmo condannati sempre, come danteschi dannati, a ripetere tutte le faticosissime esperienze che poi, lentamente, la nostra memoria conserva e sedimenta come “abitudini”, senza più ritornarvi sopra, per potersi dedicare alla ricerca del “nuovo”
In questa prospettiva, l’abitudine è un “bene” necessario allo stesso dinamismo della vita, perchè essa si propaghi e si proietti continuamente verso nuovi orizzonti. E’ come un benefico “risparmio di energia”, che il nostro io può destinare al progresso.
Fra l’altro, l’abitudine ha anche un potentissimo valore affettivo perchè costituisce la trama del nostro passato, della nostra storia, della nostra identità. Ciò vale anche per i popoli. Un popolo senza “abitudini” sarebbe un popolo senza identità, senza sicurezze di appartenenza e di continuità ad un proprio serbatoio di “usi e costumi”.
E, come accade per gli individui, così anche un popolo non potrebbe mai progredire senza muovere dall’identità costituita dal proprio sistema di abitudini, che i Romani denominavano “consuetudini”.
Tuttavia, se l’abitudine è la pre-condizione che rende possibile ogni progresso, è anche vero che può trasformarsi in un “richiamo vischioso”, in una specie di “canto delle sirene”, in grado di far “naufragare” ogni desiderio di progresso in una sorta di sonno senza futuro.
Ciò accade quando l’abitudine diventa stanco ritualismo ripetitivo, fine a se stesso, che impigrisce l’anima e la rende torpida, fino a spegnere ogni spinta verso il cambiamento e la trasformazione. In questo caso, l’abitudine è luogo di prigionia, non più promessa di libertà.
Questa ambiguità dialettica che l’abitudine racchiude in sè, come un “Giano bifronte”, costituisce il fascino e, nel contempo, anche l’insidia mortale di un “tema” che accompagna e accompagnerà sempre la nostra vita.