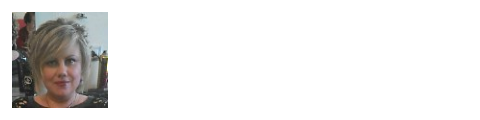Un’opera letteraria non può essere osservata come una “cartella clinica”, o come un “diario” della vita intima dello scrittore. Sarebbe fortemente riduttivo Sicuramente non esiste opera letteraria dove non sia rintracciabile la presenza di una componente autobiografica dell’Autore, ma chiedersi se l’Autore abbia veramente vissuto i sentimenti da lui attribuiti ai personaggi della sua opera, sarebbe come chiedersi se Manzoni abbia mai insidiato fanciulle indifese come Lucia, o, peggio ancora, se le abbia mai rapite veramente per imposessarsene…. Ogni opera letteraria deve essere “gustata” per ciò che è : un libero prodotto della fantasia e dell’immaginazione del suo Autore, non un “réportage” con intendimenti “clinici” della sua vita intima, o, peggio ancora dei suoi eventuali “complessi” , mi astengoi fermamente dal compiere una simile “contaminatio”, cercando “interpretazioni” che sarebbero tanto di “vivisezione”…..
E’ verissimo che molte opere sono nate per esternare stati d’animo e ideologie dell’Autore. Ma nel momento stesso in cui tali stati d’animo vengono “trasformati” in opera letteraria, se ne vanno per il mondo con una propria vita autonoma. Il lettore, leggendo, può avvertire le più svariate reazioni emotive, ma queste non riguardano più l’Autore, ma il Lettore e la sua stessa vita intima
L’opera d’arte, “ogni” opera d’arte, nasce sempre da uno stato d’animo o da una convinzione ideologica. Ma la “forma” (letteraria, plastica, pittorica ecc.) che l’Autore poi dà alla propria creazione, diviene autonoma ed entra nel “mondo del possibile”, e come tale deve essere gustata, dimenticandosi – quasi – della “persona reale” che l’ha creata. Io in questo sono rimasta un po’ crociana, e ci credo. Benedetto Croce ha sempre parlato della cosidetta “autonomia” dell’opera d’arte, intendendo con questo dire che la vera opera d’arte non può essere “ridotta” a morale, economia, psicologia, religione, o, comunque, a qualunque altra “categoria dello spirito” (come lui diceva) che Arte non è. L’operta d’arte ha una sua Universalità autonoma, che la contraddistingue da qualunque altro prodotto non-artistico.
Quando Michelangelo scolpisce il David, è chiaro che l’idea della statua gli proviene da un ripensamento dell’episodio biblico, dal tema moralistico, a lui caro, del trionfo delle forze del Bene sulle forze del Male, dalla sua anima angosciata e tormentata continuamente dal desiderio di purezza.
Ma quando la sua statua è compiuta, non è più la “sua” statua, ma diviene la personificazione di una idea di Bellezza che appartiene a tutti, cioè a tutti coloro che “per sempre”, al di là di ogni barriera di tempo e di spazio, vedranno nel David di Michelangelo il simbolo intramontabile dell’Uomo che sfida armoniosamente e vittoriosamente le forze del Male.
Così come nella Laura del Petrarca o nella Beatrice di Dante si potranno identificare per sempre tutti gli spiriti amanti di ogni epoca e di ogni spazio geografico.